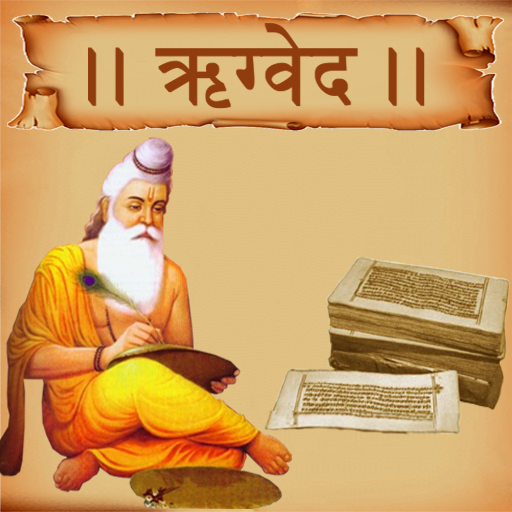
Iscriviti alla Newsletter!
Consigliamo I veda – Capitolo 1
La sezione dedicata al tema, centralissimo e fondamentale per la concezione vedica dell’essere e delle sue manifestazioni, della Parola, è composta da sette parti, che esporremo ognuna in una pubblicazione differente. A guisa introduttiva vediamo una strofa tratta dal Taittiriya-brahmana (II,8,8,5):
La Parola, imperitura, è la primogenita / della Verità, madre dei Veda e fulcro / di immortalità. Possa venire a noi / in felicità nel sacrificio. Possa ella, / nostra Dea protettrice, essere / sensibile alla supplica.
Cerchiamo di capire cosa potrebbero voler dire queste enigmatiche espressioni, o, per lo meno, cosa suggeriscono. Che la Parola abbia la proprietà di essere imperitura può semplicemente voler dire che essa esiste da sempre, ovvero da quando l’essere e il cosmo è venuto fuori dal nulla, e che esisterà coestensivamente al darsi dell’essere, ovvero alla storia del cosmo. Questo è logicamente accettabile in tale prospettiva, se consideriamo che nei Veda è detto che l’uomo venne creato insieme al cosmo, ovvero alla Terra e al Cielo. Se l’uomo è presente sulla Terra da quando questa esiste, allora anche la Parola è presente sulla terra da quanto questa è venuta all’esistenza. Ma l’aggettivo «imperitura» ha anche un gusto poetico preciso, e potrebbe voler indicare che la parola ha la caratteristica di essere stabile, una caratteristica non estranea ai fondamenti e ai principi delle cose. Tanto più che essa viene detta primogenita e madre della Verità, nonché fulcro di immortalità, oltre che divina. Insomma, attributi importanti. Devo ammettere, per incominciare, di non aver compreso fino in fondo l’affermazione: «primogenita della Verità», e di averla interpretata genericamente come l’asserzione di una stretta parentela tra la parola, la parola pronunciata e viva sulle labbra di chi appunto la pronuncia e la verità contenuta nella sruti, o meglio, la verità che emerge nel corso del rito o del sacrificio, ovvero la verità contenuta in quella parola (Parola) che nel contesto del rito sarebbe in grado di metterci in contatto con la divinità, con i fondamenti delle cose, dove, appunto, starebbe la verità. Dunque, assecondando questa interpretazione, dire che Vac è primogenita o dire che è madre, sarebbe usare due espressioni equivalenti semanticamente. Un altro modo di intendere l’espressione sarebbe giustificare l’uso del termine primogenita con il fatto che la Parola è increata e indipendente da chi la pronuncia, dal momento che viene ad esistere ancora prima del resto, quando si dà il passaggio dal nonessere all’essere, e sarebbe così antecedente la stessa Verità (o ordine del cosmo), la quale, se è dipendente dalla Parola dei Veda, per essere tale deve pur essere predicata. Che poi la parola sia fulcro di immortalità, l’abbiamo già potenzialmente spiegato. Essa viene a noi nel sacrificio, essa, in un certo senso è la divina, è qualcosa a cui ricorrere per ottenere protezione, per stare nella verità. Dobbiamo però distinguere due figure della Parola: la figura della divinità e la figura di mediazione per la divinità. Credo di poter dire con correttezza che la Parola è entrambe le figure. Vediamo la prima: siccome la parola è Dio, lo stesso Brahman, l’affermazione della realtà sul nulla, una potenza infinita, allora noi uomini abbiamo bisogno dell’intermediazione del sacrificio al fine di entrare in contatto, nella verità, con essa, ovvero al fine di farla venire a noi. Questo mi pare vogliano dire le espressioni: «possa venire a noi, in felicità nel sacrificio. Possa ella, Dea, essere sensibile alla supplica». A questo proposito si impone un ragionamento sull’identificazione tra, da una parte, il principio divino, primo inizio, dunque mistero ed enigma, e, dall’altra, la Parola. Potremmo intendere questa uguaglianza come la riduzione dell’enigma fondamentale (come fu che l’essere venne fuori dal non essere?) ad uno pseudo-problema linguistico, ad un problema del linguaggio, della parola. L’enigma potrebbe poter essere tale solamente perché lo possiamo formulare, ma non essere reale. Ma c’è un’altra, più diretta e più probabilmente corretta strada interpretativa percorribile: il mistero non è fatto di parole ma riguarda la Parola, Parola che è l’universo intero, sicché l’enigma fondamentale può essere formulato diversamente (come fu che la parola venne fuori dal silenzio?) senza cambiarne la sostanza per così dire ontologica. La presenza della parola sarebbe il mistero primordiale.
Dovremo però anche tenere a mente che la liturgia è composta essenzialmente di parole; l’atto religioso vedico più che un’azione che acquista senso in sé, nel suo crudo compimento, senza la mediazione di un significato espresso verbalmente e compreso (come potrebbe essere il caso nel rito cristiano), è un’espressione verbale al cui significato (manifesto) sì dà piena importanza. La Parola è l’atto religioso perfetto, perché è un atto che si compone di un significato intellettuale da una parte e di un portato emotivo e simbolico dall’altra – essa è infinitamente più potente ed espressiva di qualsiasi atto fisico, nel contesto rituale. Dovremo tenere conto dunque anche della seconda figura: la parola come mediatore per la divinità. Solo la Parola sarebbe in grado di collegare l’uomo con la divinità, come, all’interno dell’uomo, sarebbe in grado di collegare il corpo con la mente, come nel cosmo, sarebbe in grado di unire la Terra con il Cielo. Questo potere mediatore della Parola sarebbe un tratto comune riconosciuto dalle più diverse tradizioni religiose, ad esempio nella riflessione sui nomi di Dio. E qui faccio riferimento a nozioni esterne all’ambito Veda, cosa che ho cercato e cercherò di fare il meno possibile in queste pubblicazioni, che vorrebbero proprio essere uno sforzo di applicare la ragione per così dire nuda alla materia dei testi vedici; ma il veto che mi sono imposto deriva anche dall’esigenza di restringere il discorso all’essenziale, senza pure rinunciare alla completezza ed esaustività, e dunque dall’esigenza di non allargare il discorso alle nozioni provenienti da altre esperienze culturali o religiose, magari correndo il rischio di farlo in modo inappropriato o cedendo a parallelismi, analogie, similitudini, attualizzazioni anacronistiche e facilmente fuori luogo.




Be First to Comment