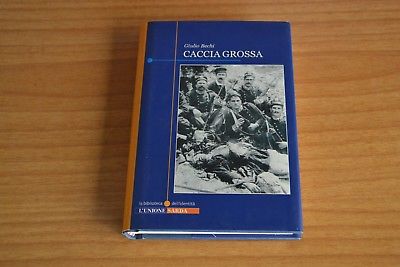
Iscriviti alla Newsletter!
Storia autobiografica del tenente dei carabinieri Giulio Bechi, toscano di origine, spedito in Sardegna per motivi non precisati. La storia si apre con Giulio che racconta dei propri sentimenti al principio del suo “viaggio” nel centro Sardegna, agli inizi del 1900. In cerca di una donna, che, comunque, non ricambia il suo affetto, Giulio Bechi lascerà il continente per giungere in una terra difficile, la cui civiltà è arcaica, i cui sistemi di comunicazione socialmente riconosciuti non lasciano molto spazio alla galanteria. Ma, soprattutto, sono la povertà, l’indigenza e il banditismo a costituire l’essenziale di quella vita che si stenta credere appartenga ad un paese che fa parte della più civile Europa. Il “viaggio” e il soggiorno di Bechi si trasformano nell’occasione di una riflessione sistematica sugli usi e costumi del centro Sardegna dell’epoca, pensieri e riflessioni di un uomo acculturato, avvezzo ad un livello di sofisticazione sociale diverso da quello dei paeselli del Supramonte.
Becchi è dominato dall’immagine della donna sarda, del pastore, del bandito e cerca, senza riuscirci pienamente, di razionalizzare tutte queste “figure” caratteristiche di un mondo nel quale la miseria, la povertà, la superstizione, la sporcizia, la disorganizzazione, la solitudine, la forza bruta, l’ignoranza sono l’essenza stessa di una società ancora, per molti tratti, primitiva. Ma è la figura del bandito che primeggia in questo resoconto.
E lì tra un sorso e l’altro, come una ciliegia tira l’altra, mi sfilano davanti le storie rinnegare la razza umana: un ragazzetto scannato, mutilato ferocemente dai Serra Sanna, perché avea trasgredito, l’innocente, a un loro bando; una donna col bambino al petto, freddata con una fucilata dal Solinas; un dorgalese colto come un passero sopra un albero, perché sospetto di spionaggio; la testa spiccata, passate le guance con un giungo, appesa a un ramo: uno strazio di corpi inermi, crivellati in un trastullo di ferocia, di membra e di tronchi composti a osceno trofeo: e ciò in pieno sole, spesso nell’abitato, nei campi, fra i gruppi di miettitori, i quali assistevano senza un gesto, senza voce e lascavano che l’assassino si allontanasse tranquillamente.[1]
Avere un bandito in famiglia era più e meglio che avere uno senatore o ministro. I piccoli lo temevano, i potenti lo spalleggiavano; un tacito patto solidale legava la macchia al villaggio, alla città. -Io aiuto te latitante, purché tu aiuti me a procacciarmi potere e ricchezze -. E si vedevano allora tante sostanze venir su come i funghi dopo un acquazzone d’estate; gente che era in piazza all’elemosina trovarsi in qualche anno con delle terre al sole e del bestiame ai pascoli. E la famiglia del latitante, sulla quale si riversava principalmente tanta manna del cielo, era il perno su cui girava il meccanismo diabolico del brigantaggio. Ma ora succede a rovescio [dopo che imposero la confisca di tutti i beni dei familiari dei latitanti]: la famiglia è la prima ad essere tassata, sequestrata come ostaggio, e il bandito viene così a trovarsi allo scoperto. Anzi sono gli stessi parenti, i quali ora lo spingono alla resa.[2]
Appena arrivo, il collega del distaccamento, un toscanino ridente e roseo, mi conduce a visitare il posto dove hanno fatto l’ultima grassazione. – Non ti posso mostrare altro, – mi dice, – è l’unica specialità del paese. E qui di fatti ne menano vanto come di un’impresa guerresca. Ci vanno anche i benestanti e i sindaci e i parroci per guadagnarsi popolarità, e i giovanotti per farsene una gloria con le belle e… per trovar moglie. Eì il loro modo di correr la gualdana, di spezzare una lancia, di conquistarsi un cuore. Le ragazze alle feste se li ammiccano tra di loro, dandosi nel gomito. – Quel lì, vedi, ha tre, quattro bardane [abigeati]. Lo dicono un uomo abile.[3]
Il libro, corredato da note, intende fornire un’immagine sommaria di quella che doveva essere l’esperienza di un carabiniere agli inizi del XX secolo, inviato dall’Italia per imporre la “civiltà” a quel popolo che non si spiega bene, né si integra nel nuovo panorama uniformato dell’Italia liberale. Infatti, a differenza che il precedente regno piemontese, dopo l’unità c’è, comunque, una certa volontà, da parte delle istituzioni, a porre un ordine stabile e “civile”, regolato da leggi e da usi e costumi sociali, che, precedentemente, non era tra gli obbiettivi dello Stato. E’ lo Stato moderno, quel mastodonte burocratico e sistematico, che entra dentro una civiltà arretrata, dal punto di vista culturale, sociale e materiale.
Anche da un punto di vista religioso, la condizione della Sardegna risulta peculiare, ancora inframmezzata dalla superstizione ancestrale, fondata su idoli e non su norme “scritte”, come vogliono le religioni mondiali formalizzate, rese canonicamente rigide a tra il 1800 e il 1900. La religione cristiana s’impose, soprattutto, nei centri urbani, dove il ruolo del prete e del vescovo riuscivano ad imporsi ad una società stabilizzata da un’economia agreste e non seminomade, com’era il caso delle popolazioni del centro. A questa concezione arcaica della religione, cioè come di un mezzo naturale per contrastare il malocchio e le forze naturali, i religiosi locali costruiscono il proprio prestigio, istituendo i sistemi migliori per imporre il proprio dominio sulle potenze dell’oltretomba:
E’ celebre il parroco di Lodine, minuscolo e miserabile paesello delle montagne nuoresi. Da questo prete giovanissimo accorrevano i più terribili latitanti, sia per consulti e per esorcismi, sia per essere forniti di amuleti pagati a caro prezzo… con le decime del bottino. Il parroco di Lodine era la sibilla del Sassarese. Un latitante gli esponeva il suo proposito di vendetta, di rapina. TOsto il bravo prete cadeva in deliquio, poi si scuoteva dalla sua estasi divinatoria e, ore fremente, pronunciava gli oracoli. Se gli pareva che la cosa non fosse conveniente: -Veggo spade e cannoni- esclamava – e voi siete in pericolo… -. Se invece l’impresa prometteva bene: – Veggo le stelle del cielo azzurro… S’avversariu est un omini mortu![4]
Gli usi e costumi particolarmente curiosi vengono riportati dal Becchi con una discreta lucidità e sospensione di giudizio:
Quando a un Orunese cade un dente – mi spiegano – egli va alla sua chiesa, fa un bucolino nell’intonaco greggio del muro e ce lo ficca dentro. Quel dente diviene sacro per tutti ed è sacrilegio toccarlo. Così nel giorno del Giudizio, allo squillo delle sette trombe quei paesani e quei semplici pastori e gli avi degli avi si troveranno tutti là, raccolti all’ombra della vecchia chiesa, dove gurono battezzati cristiani, dove per la prima volta pregarono e, innanzi di presentarsi al cospetto di Dio, ripiglieranno i loro Denti.[5]
D’altronde, la condizione umana doveva apparire alquanto incomprensibile, agli occhi di un uomo la cui nascita e crescita è iniziata e conchiusa in un ambiente urbano, nel quale la legalità o, almeno, la sua idea, insieme all’implicita necessità di dare una forma regolare ai rapporti sociali, così non sorprende di ritrovare curiose osservazioni sui problemi del mondo pastorale:
Ma che vuole accordare, per carità! – interruppe il capitano. – Mi vien da ridere quando sento parlare di cooperative, di unioni, di consorzi agrari… Che volete accordare, se non dico nello stesso paese, ma nella stessa casa, nella stessa famiglia non si trovano due che vadano d’accordo? Giri giri, vedrà: vedrà che fermento di odio, di vendetta, di rancore tenace bolle sotto queste barbe. E’ assurdo per me parlare di questione economica, se prima non si risolve la questione morale. Educate, educate prima, fatelo capire il vantaggio della concordia, di associarsi nel bene comune: metete a contatto questo popolo con altri attivi, fiorenti e civili.[6]
La condizione della donna non poteva definirsi pienamente paritaria, né, d’altronde, viene riportata con particolare cura etnografica, giacché il Becchi continuamente fa intrusioni, tra le reminescenze letterarie e una sua forma peculiare di romanticismo, grazie alle quali non è lecito trarre giudizi certi. D’altronde, anche indirettamente, si possono cogliere particolari di interessanti, come quando fa riferimento al sistema sociale di dichiarazione del partner alla famiglia dell’amata, una specie di farsa incentrata sulla simulazione e sulla metafora pastorale dell’agnello smarrito, che viene ritrovato dal pastore (p. 23). Interessante, sempre per avere un’idea sommaria di quella che era la condizione delle donne, è il seguente passo:
lo stato della donna, tu lo sai, è l’indice più sicuro della civiltà di un popolo – ebbene le donne di qua portano la benda sul viso, non ti guardano in faccia e non ti dicono buenos dias, a sentir loro e i loro compari, serbano ed esigono a prezzo di sangue una fedeltà antica, ma in realtà… in realtà vengono assai volentieri a Canossa, pur che si sappia opportunamente cercare… una contessa Matilde. Qua, più che altrove, la tanto vantata morale è tutta nel salvarsi dalle forbici della maldicenza, è tutta una finissima ipocrisia, che si rivela anche nel vestito, in quel velarsi quasi completamente la faccia e nel lascia intravedere con grazia le bellezze del seno. A Orgosolo, a Oliena, a Galtellì, a Orosei, a Dorgali, a Orune… sono fior di ragazze, le quali fanno le ritrose tra i compaesani e poi l’inverno emigrano, cacciate dalla miseria e dalla smania del vestito bello, e tornano con un zipone fiammante sulle spalle e con un gruzzoletto nel seno. Aggiungi a questo la barbara usanza medioevale, che vive ancora nei paesi del centro, di fidanzare le fanciulle appena nate, a uomini già maturi, per estinguere antichi rancori; sì che si vedono dei vecchi patriarchi accoppiati a bimbe piccine, esili, sfiorite prima ancora che sbocciate.[7]
Da un punto di vista “attualizzante”, sono rilevanti alcune osservazioni sulla monotonia della vita e sulla solitudine di chi lascia un paese per andare in un altro, condizioni, evidentemente, proprie della natura umana e non del proprio tempo. Il Becchi, infatti, si lamenta come nessuno, al suo paese, gli scriva una lettera o gli mandi un giornale per tenerlo aggiornato ai fatti del paese. Come pure il carabiniere si lamenta della ripetitività dei giorni che passano, sempre uguali, sempre con le stesse facce, determinate dagli stessi tempi. Insomma, la solitudine e la monotonia sono sentite anche da una coscienza del 1900, che non può certo dirsi pari a quella di un Leopardi e, per ciò, molto più capace di restituire quel che era il “vissuto” di un uomo qualunque, solo un po’ più volonteroso di altri.
La figura del brigante viene riportata senza particolari apici di intelligenza, né di brillantezza antropologica, cosa che, d’altronde, non doveva riguardare necessariamente un uomo dell’arma che ancora rivendica, tra le azioni encomiabili, quelle “guerresche”. E non perché il Bechi sia un uomo particolarmente insensibile o guerrafondaio, anzi, semplicemente egli riflette appieno quelli che dovevano essere i sentimenti e i pensieri del suo tempo, proprio perché egli non era certo in grado di travalicare i confini della sua epoca, giacché non era particolarmente brillante né da un punto di vista narrativo, né da altri punti di vista. E’ pur vero, comunque, che tra i meriti del carabiniere va pur segnalata una certa integrità mentale, encomiabile, in qualsiasi uomo e in uno dell’arma in specie.
Esaurite le parole per l’autore, sarà utile soffermarci un po’ sulle “figure” presentate dal libro. Innanzi tutto, il brigante rappresenta l’eroe negativo, l’immagine negativa, eppure affascinante, di un mondo non urbanizzato la cui cultura aveva concentrato nei corpi di alcuni uomini tutta la stima del prestigio sociale. In questo senso, è preziosa l’osservazione, non senza qualche intrusione dell’autore, sul sistema di attribuzione del target sessuale delle donne: la donna, come l’uomo, segue dei parametri semiautomatici per scegliere il proprio partner e, in genere, assume quelli che si ritrova nell’ambiente sociale. In una civiltà urbanizzata sarà la distinzione di una divisa o la capacità di discriminarsi attraverso forme sociali condivise (come lo sport) a imporre un certo status-simbol condiviso. Non stupisce, infatti, che la selezione sessuale umana sia discriminatoria di alcune caratteristiche che variano da epoca a epoca e da civiltà a civiltà, sebbene tutte evitino sistematicamente certi individui, perché, comunque, esistono dei limiti imposti dalla natura stessa: gli storpi, uomini la cui capacità ereditaria sarà limitata, sono esclusi dalla gara alla donna, come lo sono gli animali deformi. Allo stesso modo, la devianza radicale alla società, la follia, l’apparenza di “malattia”, in un uomo, non sono segni distintivi di una sua potenza sessuale. Dunque, se la natura impone qualche vincolo, sono poi i sistemi materiali di vita e i sistemi sociali a determinare certe “qualità”, riconosciute su un piano di normatività sociale che chiamiamo “ideologia dominante”. Nel caso della Sardegna agropastorale, almeno fino agli anni 1900, il “prestigio” non poteva che andare a uomini la cui capacità fisica e intellettiva li conduceva a possedere più degli altri. In una società seminomade o semistanziale, il concetto stesso di proprietà privata doveva essere ben più sfumato, rispetto a quello di un mondo agricolo e, sostanzialmente, sedentario. Come le popolazioni nomadi della mongolia medioevale, così in Sardegna l’immagine dell’uomo virile è quella di una persona in grado di imporre la propria volontà con la forza su quella degli altri. Egli è un “dominatore”, giacché nessuno lo può contrastare. Un uomo, concepito in questo modo, diventa vicino ad un’entità divina, comprensibile e potente, capace di apportare grandi benefici, se amico, e grandi rovine, se nemico. Il mondo pastorale si fonda su pochi beni “solidi” e molti “mobili”. Così, il brigante non è una figura essenzialmente di “rottura” con i sistemi sociali riconosciuti, ma solo una loro continuazione; come le modelle non sono altro che un’estensione radicale dell’accettazione di certe norme sociali, piuttosto che un loro rifiuto. Il brigante-pastore, dunque, diventa un centro “energivoro” sul piano dell’immaginazione collettiva.
Il mondo pastorale non ha mai riconosciuto appieno le leggi delle società “civili”, intese come società di “città”, di “cittadini”. I pastori e il loro mondo circostante non appartiene propriamente a nessuna legge perché la proprietà privata, essendo mobile, è di difficile definizione. Se la terra non si sposta, e il contadino deve far di tutto per coltivare il suo appezzamento, il pastore va alla continua ricerca di territori buoni per il pascolo: mentre il contadino deve piegare la forza della natura a suo vantaggio, e lo può fare solo nel tempo e con la tutela degli strumenti materiali idonei per farlo, il pastore, viceversa, deve assecondare e seguire i voleri continuamente mutevoli delle condizioni naturali. Da questo, si comprende pure come la stessa religione cattolica si imponga con difficoltà nell’entroterra sardo e lo fa sempre con forme chiare di ibridismo e commistione con riti più arcaici e legati a forme di superstizione. La superstizione, in questo senso, si differenzia dalla religione per non avere caratteri stabili nella concretezza, ma ne mantiene l’unicità del fine: la possibilità di porre un argine alle forze imponderabili della natura e dell’oltretomba. La religione cristiana si afferma facilmente in civiltà sedentarie perché i singoli riconoscono la sensatezza di norme come quelle mosaiche, piuttosto che quelle di Gesù, inoltre, con l’intermediazione dei santi, essi vedono il sistema di intercessione tra la realtà e il Dio onnipotente, ma astratto e lontano. In una società nomade e pastorale il cristianesimo trova molta più difficoltà ad attecchire perché gli stessi fondamenti normativi non riescono a farsi accettare in una società in cui i singoli sono troppo pochi e dispersi per riconoscere la necessità di avere delle normative, morali e legali, che siano capaci di imporsi come arbitri imparziali del comportamento umano. Semmai le leggi cristiane costituiscono un controsenso, rispetto a quell’idea secondo cui è la volontà del singolo e il singolo stesso a dominare il mondo e non una forza assoluta ma lontana, difficilmente comprensibile. La forza e l’ingegno materiale, l’egoismo e la capacità di attrarre a sé la sorte sono i principali attributi dell’uomo “prestigioso” e non l’uomo capace di rispettare le leggi.
Il mondo pastorale è immortale, perché economicamente stabile, ma è anche fluido, perché a bassa densità demografica e, di conseguenza, rarefatto sul piano della densità culturale. Le uniche forme di civilizzazione, in termini di raffinatezza della strumentazione tecnologica e sociale, sono, guarda caso, proprio gli artefatti carichi sul piano del prestigio: i vestiti e i pochi oggetti indispensabili, tra cui le armi da fuoco.
La civiltà pastorale, dunque, è in grado di mantenere i suoi costumi sociali inalterati proprio perché la sua evoluzione, sul piano economico e sul piano sociale, è immutabile. Essa segue molto più da vicino i ritmi della natura che non quelli umani. Se è vero che gli allevatori mischiano sempre il sangue delle loro bestie a quello delle migliori, è pur vero che la selezione artificiale sugli animali segue, comunque, il tempo della riproduzione degli armenti, dunque, un tempo lungo i cui vantaggi sono, assai spesso, intangibili da parte dei singoli ma danno un chiaro vantaggio a livello comunitario, nel tempo a venire.
Se la civiltà dell’entroterra ha conservato in buona parte intatti i suoi usi e costumi ancestrali, non è solo né principalmente per l’inedia dei suoi individui, quanto, assi di più, per le caratteristiche di una società demograficamente povera e la cui capacità di generare nuove idee si scontra, da un lato, con l’esiguità di persone che possono farlo (studiosi e curiosi, in generale) e con la povertà delle relazioni che sussistono tra le persone. I paesi vengono continuamente descritti come somme non omogenee tra individui, costretti, variamente, ad arrangiarsi come possono da soli e non in forme di cooperazione complesse. Lungi dall’essere l’immagine della collettività agreste, il mondo pastorale è estremamente pratico, le cui capacità individuali si pesano sulla bilancia dell’efficienza a livello personale. Per gestire un pascolo bastano pochissime persone e non richiede una regolamentazione ferrea che, anzi, impone dei problemi pratici evidenti, sistemi di cooperazione, dunque, che sono, invece, necessari sia in ambito agricolo che industriale. Ecco, dunque, un’altro motivo per capire come un uomo feroce, come il bandito-latitante, assume un significato simbolico, rispetto ad un mondo che non lo può riconoscere come positivo neanche sul piano delle idee. Non per niente il cittadino Becchi rimane continuamente incuriosito e disgustato dalla figura del bandito che, ormai, non è più un uomo tra gli altri, ma un “deviante”, inserito nella categoria del “malato sociale”, da “curare”.
Solitudine, individualismo, solipsismo dei materiali intellettuali, povertà delle connessioni tra persone. A ciò, va aggiunta anche la difficoltà, in un periodo preinformatico, pre linee telefoniche, a far circolare nuovi costumi sociali e nuove “storie”, siano esse morali, sociali o tecnologiche. Immaginiamoci nel 1800 a Cagliari. Un uomo deve andare a Nuoro per ragioni commerciali. Egli ci va una o due volte l’anno e porta con sé delle merci della città, portatrici, indirettamente, di idee. Come arriva a Nuoro, parlerà con poche persone, generalmente quelle che ha già conosciuto, e con le quali avrà a parlare di faccende commerciali ed essenzialmente pratiche. Nell’ambito di una società già chiusa, perché le idee sono quelle che si sono solidificate nel tempo, nell’ambito di un mondo economico di nulla capacità, incapace, dunque, di comprare artefatti di livello superiore (fatto salvo che per le armi da fuoco) ecco come le poche idee non direttamente interne alla comunità, riescano a circolare con difficoltà e con molta lentezza. Con il fluire del tempo, la stratificazione sociale e l’immobilismo economico indurranno tale popolazione alla stasi dei costumi e delle idee. E, a quel punto, arriva il Becchi a fare da “osservatore” di un mondo di “altri tempi”, di cui si poteva lecitamente dubitare l’esistenza all’interno di un’Europa che vanta città come Londra e Parigi, dotate di sistemi di treni metropolitani!
In conclusione, da un punto di vista letterario, il libro del carabinier Bechi lascia molto a desiderare, sia sul piano dei contenuti sia sul piano propriamente stilistico e narrativo. Una lingua piana, condita di parole comuni e continuamente sollecitata a produrre un linguaggio assai povero, lascia perplessi i lettori esteticamente esigenti. D’altra parte, a livello contenutistico, non si può certo dire che i continui rimandi alla solitudine sessuale del carabiniere, non si sa se per ragioni di “letterarismo” o, piuttosto, di genuina necessità umana, riescano a rendere più gradevole la lettura. Inoltre, della Caccia grossa si parla in due o tre capitoli, di cui due sono quelli finali. Rimane, comunque, un libro storicamente interessante, che consente di tracciare un quadro, sebbene in controluce, di quella che doveva essere la società pastorale sarda almeno fino agli inizi del XX secolo.
[1] Bechi G., Caccia grossa, Unione Sarda, 2003, p. 26.
[2] Ivi., Cit., pp. 56-57.
[3] Ivi., Cit., p. 66.
[4] Ivi., Cit., p. 33.
[5] Ivi., Cit., p. 39.
[6] Ivi., Cit., p. 75.
[7] Ivi., Cit., pp. 132-133.




Be First to Comment