Leggi anche Leggere i Nobel alla letteratura – Gabriel García Márquez
Oggi più di ieri e domani più di oggi, l’artista contemporaneo deve fare i conti con l’originalità della sua opera, come impone, infatti, l’ingombrante produzione dei suoi predecessori. Provo a spiegarmi meglio con un estremo. Immaginiamo come doveva essere nell’antichità, agli albori di una qualsiasi forma d’arte, quando l’uomo, che con essa andava cimentandosi, proprio perché agli albori, poteva esplorare ampie praterie di novità. Quello che nasceva dalla sua creatività per tutti era originale, certo poteva non piacere, ma non gli si poteva negare l’innovazione.
Poi vennero altre persone che si dedicarono alla stessa arte, così quella prateria iniziò ad essere sempre più battuta. Ai giorni nostri, dopo secoli di produzione e schiere di autori, un nuovo artista ha certamente difficoltà a scoprire sentieri ancora nascosti dall’edera, e per fare ciò spesso rischia di essere volgare, inelegante e di travestire il brutto da bello.
Le stesse considerazioni si possono fare in molti altri campi, si pensi alla filosofia: è possibile oggi proporre un pensiero del tutto nuovo? O all’esplorazione: al secolo son state scoperte tutte le isole. Solo la scienza e il progresso sembrerebbero poter avanzare indefessamente verso l’inesplorato.
In realtà tutto ciò è una falsa verità. Perché ogni nuova società che viene porta con sé nuove mentalità, più aperte, che permettono slanci artistici prima impensabili. Quell’ingombrante e preesistente produzione, che pare limitare l’artista contemporaneo, (a meno che questi non si ponga come epigono o accetti le accuse di plagio) può diventare invece un vantaggio, un punto di partenza, un’ispirazione, un elemento da migliorare, riadattare o reinterpretare. Il già fatto diventa così la base del nuovo: un vantaggio sul quale l’uomo dell’antichità non poteva contare.
Un fattore correlato a questo sono i temi. Ci sono temi così ricorrenti per cui ogni nuovo autore che li tratta si muove tra il pericolo della banalità e quello di essere ridondante. Un musicista è molto a rischio su questo fronte, dovendo destreggiarsi con un numero finito di sole sette note. Ci si chiede se, date le innumerevoli melodie già composte, risulti ancora possibile inventarne di nuove sempre con le stesse sette note. Da secoli, principe dei temi ricorrenti è l’amore, con tutte le sue rime annesse.
Com’è difficile apportare qualcosa di nuovo ad alcuni temi, altrettanto difficile è per un artista desistere dal trattarli. In lui spesso ha la meglio una incontrollabile necessità di dichiarare il proprio giudizio. L’assenza della sua espressione equivarrebbe ad un’occasione sprecata per affermare il proprio status!
Un altro dei temi più ricorrenti della produzione artistica è la Shoah. Come per l’amore, anche su questa, l’artista ha sempre qualcosa da dire. Nell’arte della letteratura, a quanto ammonta la prosa e la poesia sulla Shoah? Se si scevra la composizione di quanto è suggestione propria dei fatti storici, qual è il contributo suggestivo addizionale dell’artista? In quante di queste opere emerge il valore dell’autore che lo innalza dalla comoda condizione di cronista? È possibile raccontare qualcosa di nuovo sulla Shoah?
Come un trifoglio ogni diecimila nasce con quattro foglie, esiste uno scrittore il cui nome risponde affermativamente all’ultima nostra domanda. Si tratta dell’ungherese Imre Kertész, con la sua opera Essere senza destino, meritevole del Nobel alla Letteratura nel 2002.
Il protagonista della storia è un ragazzo di nome Gyurka, nome de plume dello scrittore sopravvissuto ai campi di sterminio, dalla cui esperienza nasce appunto il testo autobiografico. Per certi versi il libro è molto simile a tanti altri che riportano le esperienze dei deportati, in cui una scrittura opportunamente asciutta mette in risalto gli avvenimenti come un mero resoconto. Tuttavia ben presto si viene colpiti dal distacco con il quale Gyurka vive l’atroce realtà nel lager, una sorta di freddezza protettiva per la sua psiche:
«Giovanotto (…) perché dici sempre che è naturale, e soprattutto per cose che non lo sono affatto!» Gli dissi che nel campo di concentramento tutto questo era naturale.
Il protagonista non esprime mai nessun giudizio sulle assurdità che pure lo circondano e che vive, non mostra risentimento neanche quando capisce l’origine dei fumi umani che vede alzarsi dai camini di Auschwitz. Per lui tutto questo è normale, logico. Ma Imre Kertész non fa le cose all’acqua di rose e l’assenza di giudizio da parte del protagonista è un rivelatore della sua cifra autoriale. Lui sa benissimo che quanto il lettore apprende dei campi di sterminio arriva come una crudelissima tragedia che lo abbatte, lo indispone e lo indigna. Pertanto dà questa verità per assunta e non spreca righe – né stile con uno spiegone inutile – per esplicitare quanto è terribilmente lapalissiano.
Un altro elemento che colpisce di Essere senza destino sono i dieci anni di stesura che ha richiesto. Se l’opera è autobiografica, e purtroppo anche il contesto, se non è stato necessario inventare niente, perché così tanto tempo? La risposta la ritroviamo nella profondità del pensiero del deportato, poiché questo atteggiamento privo di giudizio e biasimo verso i fatti accaduti nei campi di concentramento è il frutto di un percorso evolutivo interiore di grande valore. Così Imre Kertész ci offre una storia che differisce notevolmente da tutte le cronache già riportate in altri libri, senza comunque rinunciare alla brutalità di Jean Améry, sopravvissuto ai lager ma non alla sua mente; alla profondità spirituale di Elie Wiesel, “Dov’è dunque Dio?” “È appeso lì, a quella forca…”; al pensiero analitico di Primo Levi, “C’è Auschwitz, dunque non può esserci Dio”.
Allora, nel concreto, che cosa ci offre di così nuovo e originale il libro?
La risposta è preziosamente incastonata nell’ultima pagina. Poiché un pensiero così sublime non può trovare nessuna consistenza all’inizio. Si può arrivare ad esso solo dopo lunghe e profonde introspezioni, segno di una maturazione lenta, ma anche di una presa di posizione precisa che risponde al dovere dell’uomo di mirare in alto, di essere felice.
Si tratta di una filosofia finissima. Un pensiero che quando lo si coglie è capace di fermare il tempo, di stimolare la meditazione e di farci interrogare sul valore che diamo alle inclemenze della vita.
«Non esiste assurdità che non possa essere vissuta con naturalezza e sul mio cammino, lo so fin d’ora, la felicità mi aspetta come una trappola inevitabile. Perché persino là, accanto ai camini, nell’intervallo tra i tormenti c’era qualcosa che assomigliava alla felicità. Tutti mi chiedono sempre dei mali, degli ‘orrori’: sebbene per me, forse, proprio questa sia l’esperienza più memorabile. Sì, è di questo, della felicità dei campi di concentramento che dovrei parlare loro, la prossima volta che me lo chiederanno». [Imre Kertész]


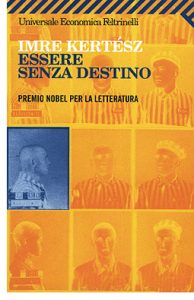


Be First to Comment