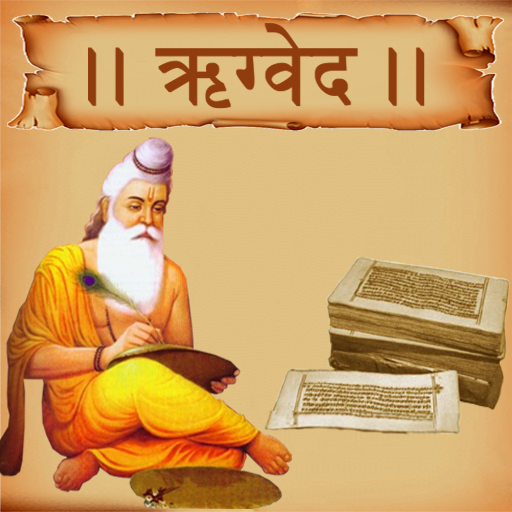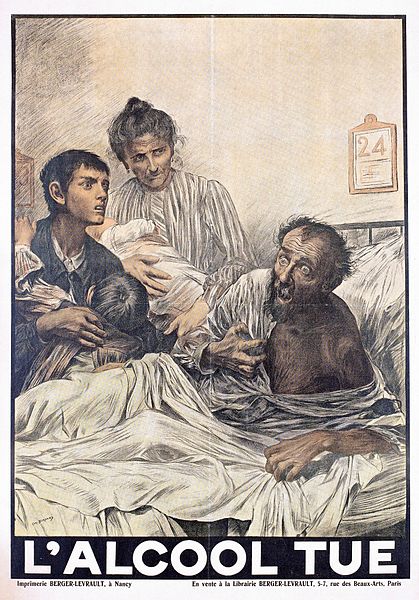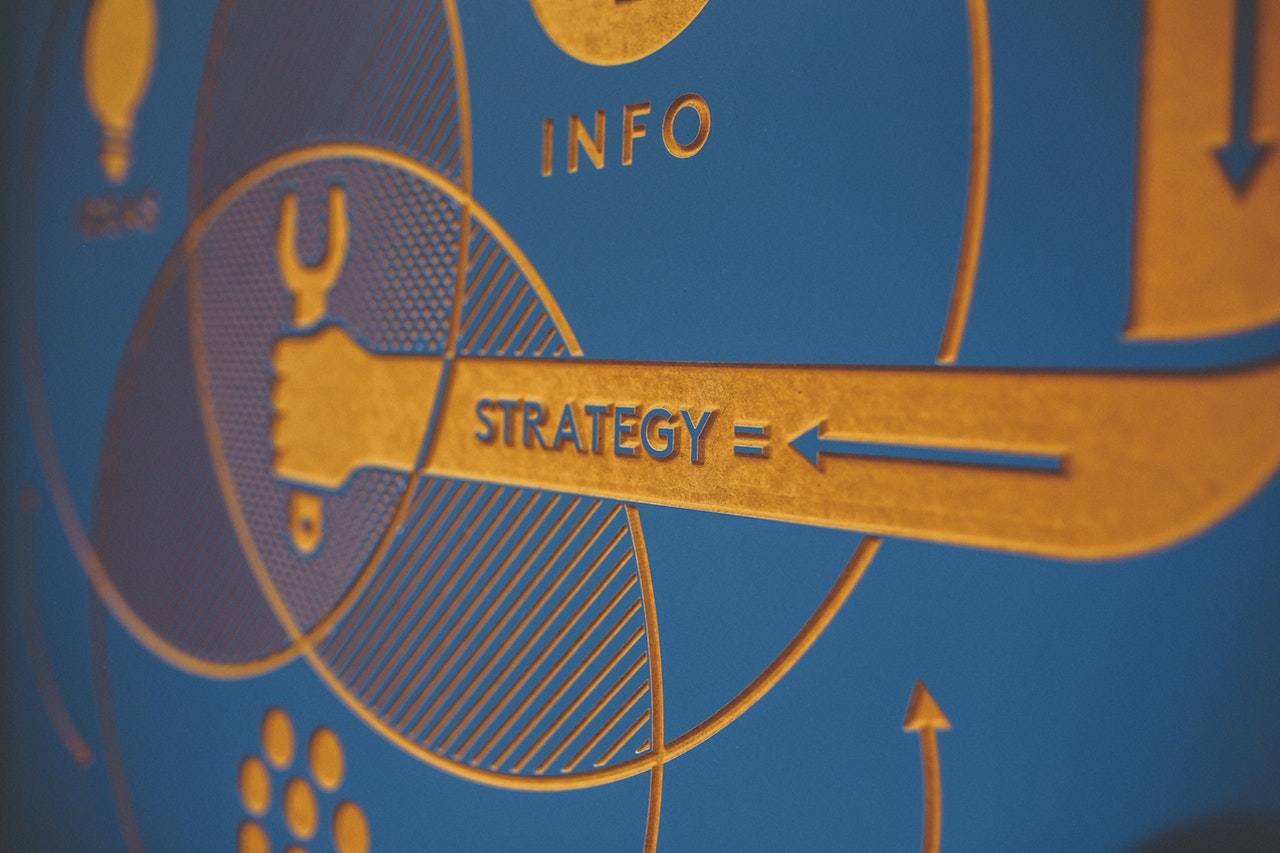
Abstract
Il controllo indiretto globale è una strategia applicabile ad ogni ambito che preveda conflitti di interesse. Già Liddell Hart propone una particolare forma di indirect approach. Come mostreremo, essa è una particolare istanza del più generale controllo indiretto globale. Per definire la nostra impostazione strategica abbiamo dovuto individuare alcuni principi generali della buona strategia, principi già ben conosciuti dagli specialisti del warfare.
Vuoi leggere un libro sulla filosofia della guerra? Filosofia pura della guerra!
Vuoi leggere questo articolo in pdf? Vai qui!
Iscriviti alla Newsletter!