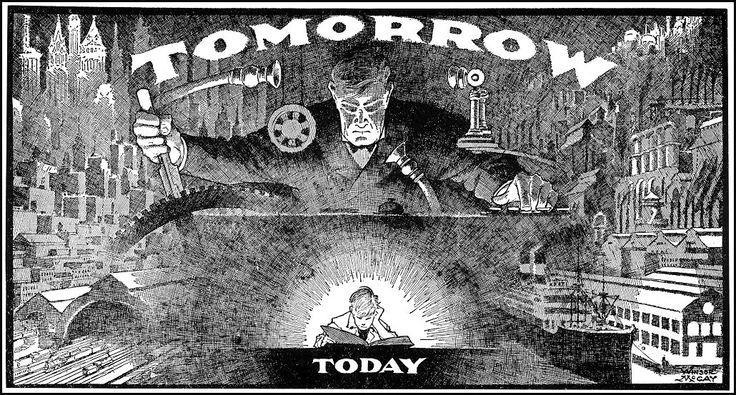Abstract
In questo articolo proponiamo una teoria causale della moralità kantiana, riconsiderando la posizione di Immanuel Kant sulla base di una certa interpretazione spinoziana della volontà umana e della libertà. L’analisi non riporta la storia delle idee ma solamente una posizione causale dell’imperativo categorico kantiano e del valore della responsabilità umana pur parte di una totalità eccedente la sua singola capacità di azione.
Il tema della libertà è uno dei più antichi dell’intera storia della filosofia. Ogni generazione filosofica, che impiega secoli per subentrare alla precedente, ha avuto la sua fitta analisi sulla libertà. Non è questo il posto per la storia dell’idea né per la ricostruzione recente del dibattito. Quanto ci proponiamo di fare, qui, è solamente fornire una analisi generale di un possibile tipo di approccio alla nozione di libertà.
Innanzi tutto, la libertà è una proprietà di alcuni esseri, tra cui forse gli esseri umani. C’è un generale consenso sul fatto che le cose non abbiano a disposizione alcun genere di libertà. Questo perché, in genere, si ritiene che la libertà abbia a che fare con una volontà, ovvero con la capacità di prendere decisioni sulla base di intenzioni. Tuttavia, allo stesso tempo, si ritiene che la stessa volontà abbia dei limiti e le sue decisioni sono influenzate da cause esterne che prendono varie forme. Quindi, una volontà libera è comunque sempre limitata. La relazione tra soggetto e mondo determina la misura della libertà, che è quindi espressa da un predicato a due posti e non è di natura categorica. Si è più o meno liberi, più o meno vincolati dal mondo.