Ci sono tre porte, con un premio dietro solo una di esse. Il concorrente sceglie una porta, ma non la apre. Sa che chi dirige…
...all we need is philosophy
Ci sono tre porte, con un premio dietro solo una di esse. Il concorrente sceglie una porta, ma non la apre. Sa che chi dirige…
Iscriviti alla Newsletter!
Consigliamo – Percorso di filosofia moderna
Se Dio non esiste, non perderemo nulla nel credere in Lui, mentre se Lui esiste, avremmo molto da perdere dal non crederci.
Una buona strada per evidenziare la distinzione tra la credenza razionale e una particolare credenza epistemicamente razionale è considerare la posta di Pascal, chiamata così dopo il filosofo Francese, Blaise Pascal (1623-1662). Il devoto Pascal voleva mostrare che la credenza in Dio fosse razionale. Per questo fine, lui propose l’argomento che nessuno ha niente da perdere, ma solo da guadagnare, dalla credenza in Dio, così che la credenza in Dio è la cosa giusta in cui credere.

Iscriviti alla Newsletter!
Consigliamo – Percorso di filosofia moderna
“Un asino affamato e assetato è accovacciato esattamente tra due mucchi di fieno con, vicino ad ognuno, un secchio d’acqua, ma non c’è niente che lo determini ad andare da una parte piuttosto che dall’altra. Perciò, resta fermo, e muore! Ma immaginiamo che uno di noi si trovi in una situazione analoga, tra due tavoli pieni di cibo e bevande[1]. Non ci dirigeremo forse subito verso uno dei due tavoli?”[2]
Per comprendere questo paradosso, è molto bene esplicitarne le premesse di fondo, cosa che non fa l’autore del libro da cui abbiamo tratto la seguente formulazione dell’antico rovello.
Iscriviti alla Newsletter!
Il poligono di Cusano è un classico argomento della filosofia rinascimentale. L’autore suggerisce l’idea che la conoscenza umana sia limitata e non possa mai giungere all’infinito. La natura è infinita, dunque la comprensione dell’uomo non raggiungerà mai la pienezza della natura, sia del cosmo che del divino.
Questa concezione prende forma in una celebre immagine: il poligono inscritto in una circonferenza. Prendiamo che al principio ci sia un triangolo inscritto in una circonferenza, triangolo non perché il più perfetto delle spezzate chiuse quanto perché è la più piccola dei poligoni pensabili.
Immaginiamo di aggiungere un lato al triangolo: esso diventa un quadrilatero. Il perimetro del quadrilatero inscritto nella circonferenza è minore della circonferenza stessa.

Scopri Intelligence & Interview di Scuola Filosofica!
Iscriviti alla Newsletter!
Consigliamo – Introduzione schematica all’epistemologia di Giangiuseppe Pili
L’articolo di Gettier inizia con una domanda polemica, rispetto a tutte quelle teorie d’epistemologia che fondano le loro analisi nella “definizione tripartita della conoscenza”: la conoscenza è credenza vera giustificata. Egli, infatti, nell’incipit del suo articolo, espone tre versioni autorevoli di definizioni che, d’altra parte, enunciano la definizione secondo tre condizioni: la condizione soggettiva (la credenza), la condizione oggettiva (la proposizione creduta è vera) e la giustificazione. La definizione è un po’ astratta e merita una metafora che, dal senso letterale, ci consenta di passare ad uno allegorico, mantenendo, però, su un piano ideale e concreto lo stesso concetto.

Scopri Intelligence & Interview di Scuola Filosofica!
Iscriviti alla Newsletter!
Consigliamo in SF I paradossi dalla A alla Z di Michael Clark
(1) Per un soggetto supposto dall’economia neoclassica vale la regola secondo cui egli sceglierà solo l’opzione che gli garantirà la massima utilità.
(2) Poniamo che un uomo ricchissimo offra 100 $ ad un soggetto.
(3) L’uomo ricchissimo pone la seguente condizione: se il soggetto rifiuta 100 $, potrà averne il doppio il giorno seguente. Ma se il giorno seguente il soggetto rifiuterà ancora, potrà avere il doppio dei soldi promessi in quel dì e così via.
(4) Problema: quando il soggetto accetterà i soldi offerti dal ricco signore posto che nel giorno seguente avrà sempre raddoppiata l’utilità attesa del giorno presente?

Scopri Intelligence & Interview di Scuola Filosofica!
Iscriviti alla Newsletter!
Consigliamo in SF Saggio su Husserl e Kandinsky di Paolo Meneghetti
Il predicato “essere bello” si usa in continuazione, soprattutto in una società che ha istituzionalizzato il suo uso per etichettare e distinguere dei fatti morali. L’estetica è sempre stato un risvolto della morale dominante, la cui chiarificazione e concretizzazione attraverso immagini serve a rendere materiale un particolare aspetto morale. L’arte, attività propria della realizzazione del bello, si è sempre trovata a suo agio tra finanziatori interessati da un certo punto di vista morale e, di fatto, nella gran parte dei casi, l’intenzione dell’artista è sempre guidata da un interesse profondamente etico. Tuttavia, esiste un campo puro in cui è lecito pensare ed analizzare i fatti da un punto di vista puramente estetico e “puramente disinteressato”, con ciò bisogna intendere: indipendentemente da tutto ciò che non riguarda puramente l’estetica. In altri termini, il predicato “essere bello” deve essere utilizzato nell’esclusivo senso estetico, indipendentemente dagli usi ibridi, parzialmente impropri, che legano il predicato ad altre proprietà, prime tra tutte, la categoria di “piacere” e di “realtà”.
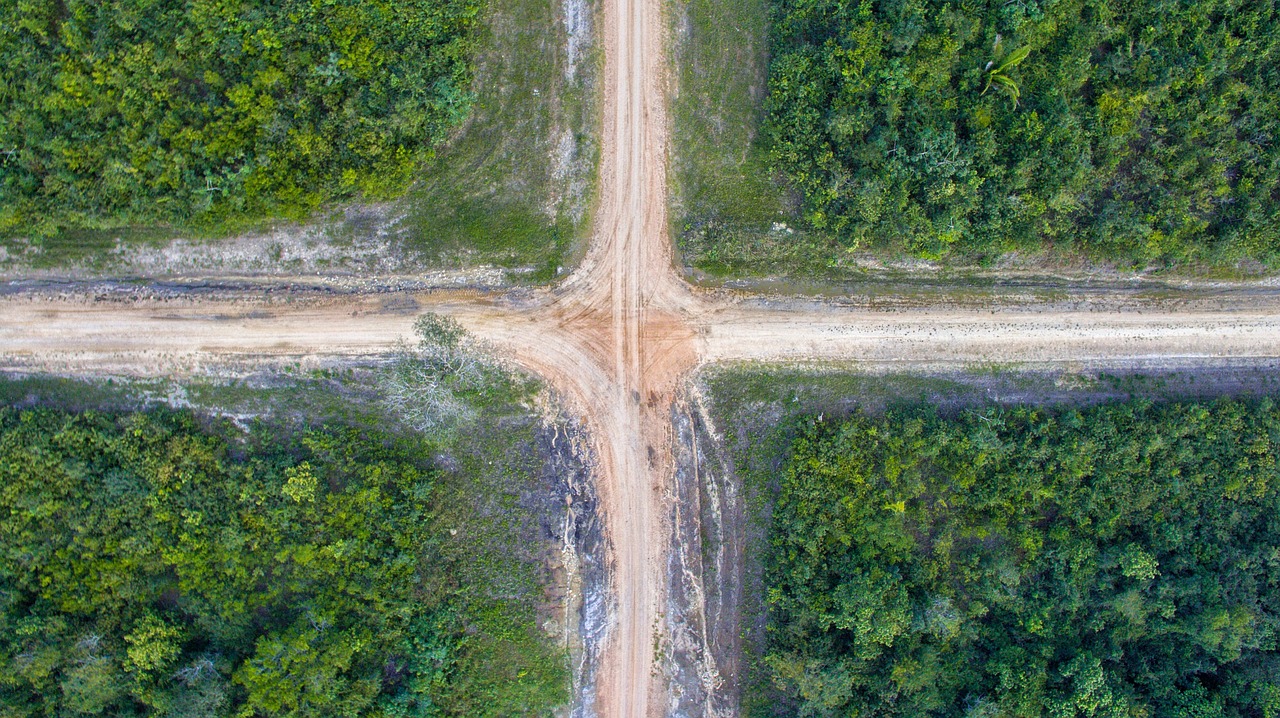
Scopri Intelligence & Interview di Scuola Filosofica!
Iscriviti alla Newsletter!
Consigliamo in SF I paradossi dalla A alla Z di Michael Clark
Chi dice “Io so che p, ma non ci credo” si sta contraddicendo perché se sa che p, allora non può legittimamente non crederci.
Il paradosso di Moore è stato battezzato così da Wittgenstein e dal grande filosofo molto apprezzato perché, secondo lui, mette in luce l’assurdità di non credere ad una proposizione elementare che esprime un fatto, se affermata: “Oggi piove, ma io non ci credo”.

Scopri Intelligence & Interview di Scuola Filosofica!
Iscriviti alla Newsletter!
Consigliamo in SF I paradossi dalla A alla Z di Michael Clark
Formuliamo il paradosso di Eutalo. Protagora acconsente di insegnare diritto a Eutalo a patto che non appena abbia vinto una causa, Protagora venga pagato. Eutalo riceve lezioni, ma al termine di queste non sostiene nessuna causa. Protagora decide di citarlo in giudizio per essere pagato.
1) Il ragionamento di Protagora (P.) era questo: se Eutalo vince, allora P. deve essere pagato per rispetto del patto. Se P. vince allora il tribunale costringerà Eutalo a risarcire P.. Dunque, in qualsiasi dei due casi, Protagora vincerà.
2) Il ragionamento di Eutalo (E.) era questo: se Protagora vince, allora E. non deve pagare perché egli non ha vinto la prima causa. Se egli stesso (E.) avesse vinto, allora era Protagora a pagare costretto dal tribunale.
Chi ha ragione?
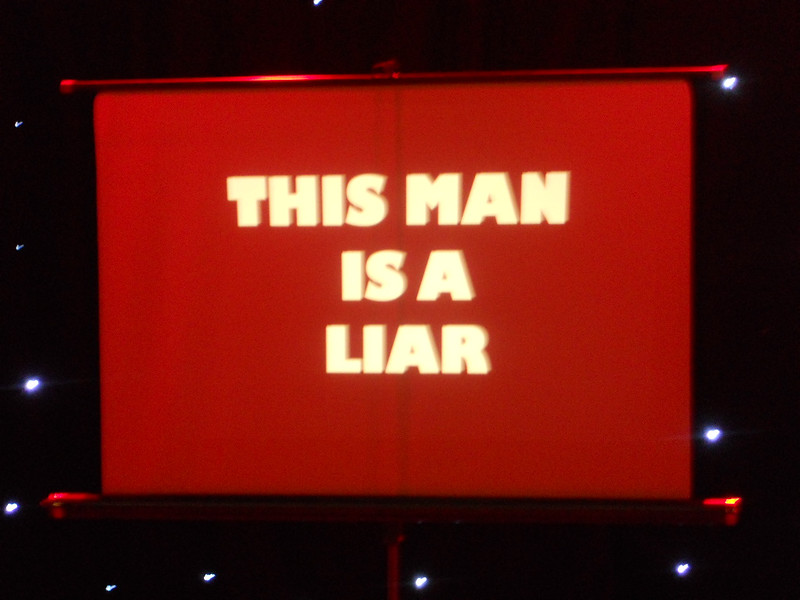
Scopri i libri della collana o i servizi editoriali di Scuola Filosofica!
Iscriviti alla Newsletter!
Consigliamo in SF I paradossi dalla A alla Z di Michael Clark e Filosofia del linguaggio – Teorie della Verità di Giangiuseppe Pili
(C) Io so che questo enunciato, C, è falso.
Se C è vero, è falso, perché lo so; perciò è falso. Ma, poiché lo so, so che è falso, il che significa che è vero. Quindi è sia vero che falso[1].