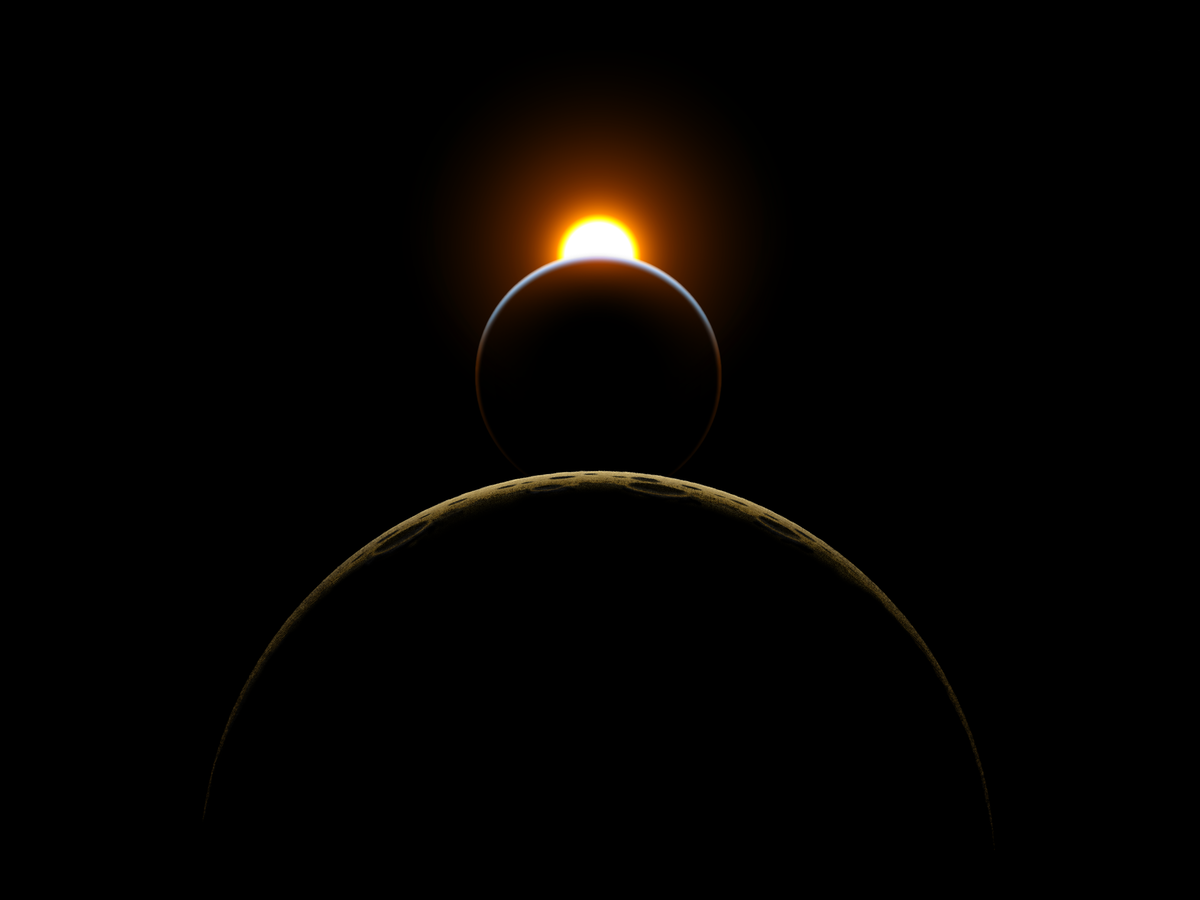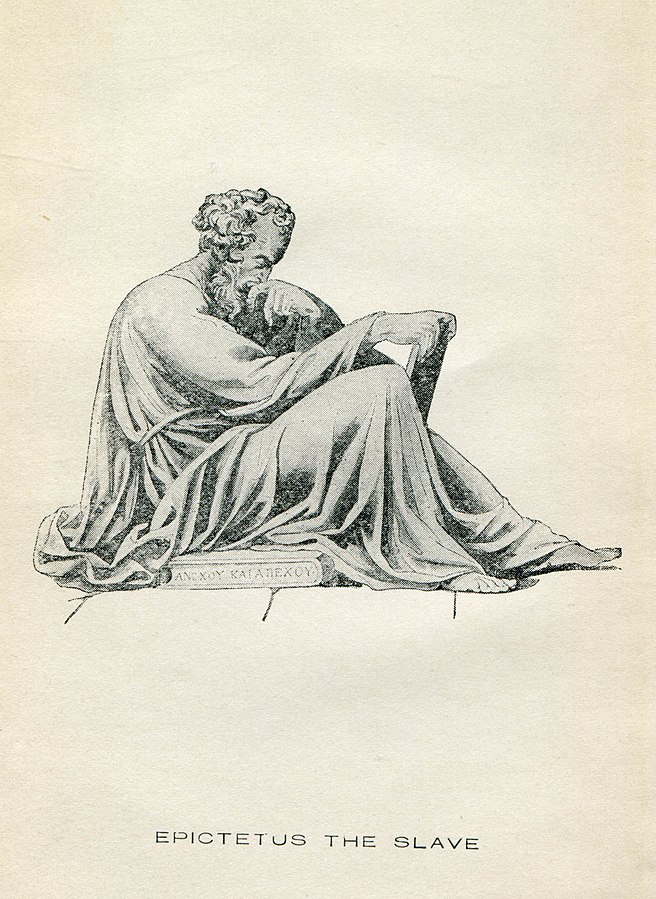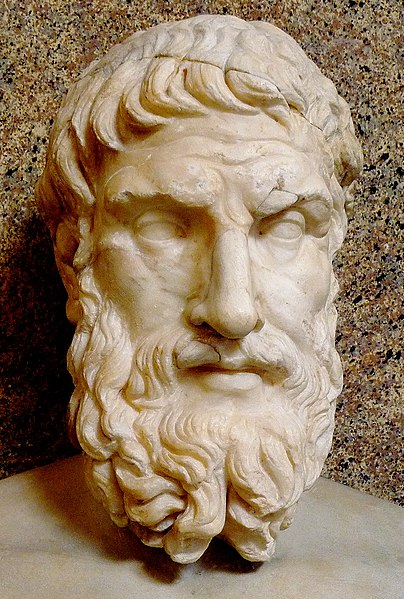La filosofia di Immanuel Kant è giustamente considerata una delle massime espressioni dell’illuminismo europeo e, più in generale, uno degli apici di tutta la storia della filosofia. Non è certamente un caso che il grandissimo compositore tedesco, Ludwig Van Beethoven, di pochi anni successivo a Kant ne apprezzasse le opere. L’autore dell’inno alla gioia che, poi, diverrà l’inno europeo, lesse la Critica della ragion pratica, fondamentale opera morale kantiana, e ne apprezzò profondamente il pensiero.
La filosofia morale di Kant si impose rapidamente come un nuovo modo di riflettere su antiche questioni e Kant stesso esplicitamente disse più volte che lo scopo intero della sua filosofia era una rigorosa fondazione della morale. Questo chiaro interesse è già presente nella Critica della ragion pura, testo non dedicato alla morale ma alle possibilità e i limiti della nostra capacità di conoscere, opera monumentale e precedente alle opere morali. Kant già introduce il tema morale nella celebre prefazione alla seconda edizione della prima critica, il cui scopo non era affatto di natura squisitamente morale ma: “…quello di sottrarre la metafisica ad ogni influsso dannoso, identificando le fonti dei suoi errori”. Il grande filosofo di Königsberg, città dell’allora Prussia, però già guardava ai problemi più profondi dell’interiorità umana.