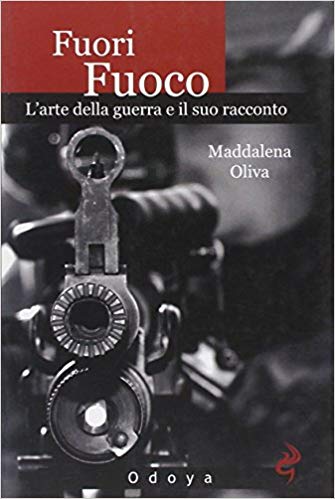
Iscriviti alla Newsletter!
Vuoi leggere la monografia che contiene questo testo? Filosofia pura della guerra!
Fuori fuoco L’arte della guerra e il suo racconto è un saggio di Maddalena Oliva nel quale viene spiegato il rapporto tra l’immagine della guerra veicolata nei media attuali e l’evento militare. Il saggio si articola in sei parti.
Nell’Introduzione Visioni incrociate tra l’arte della guerra e il suo racconto vengono presentati tre nuclei tematici ricorrenti: (1) il sistema geopolitico attuale è causa (efficiente) o effetto (nei modi) di uno stato di “guerra globale permanente” in cui i termini di “pace” e “guerra” tendono a fondersi e diventare sostanzialmente irriconoscibili:
L’ultima di queste è, a seconda delle definizioni, “la guerra totale permanente” – formula banale ma che nota una dimensione pervasiva, continuamente protratta nel tempo e nello spazio – che apre uno scenario in cui tutti i termini e le distinzioni tradizionali sembrano girare a vuoto (dalla cancellazione dei limiti fra pace e guerra, interno e esterno, civile e militare, stati in grado di “dichiarare la guerra” e stati che possono “firmare la pace”, alla redistribuzione al di là di ogni dimensione stabile dell’asse amico/nemico).[1]
(2) La modalità del conflitto si sta sempre più modellando come una forma di controllo o polizia globale, nel quale un paese più forte (USA sempre o per lo più) tende a fare ingerenza diretta nei confronti dei paesi più deboli con la motivazione esclusiva di portare l’ordine e la pace in un paese che non ha né l’uno e né l’altro. Punto di vista, naturalmente, che stravolge le vere intenzioni politiche e strategiche. (3) L’evento bellico diviene l’occasione di una produzione di spettacolo, inscenato dalla rappresentazione mediatica che, almeno implicitamente, ha perso il ruolo di testimone (e cioè il ruolo di testimone diretto della verità). I media, dunque, non solo sono parte in causa nell’evento bellico, cioè all’interno della definizione degli stati di interesse costituiti che favoriscono la guerra, ma sono anche un mezzo grazie al quale la guerra viene descritta in modo da risultare politicamente e strategicamente utile: “Viviamo le guerre in quanto rappresentazioni, le pianifichiamo come fossero spettacoli televisivi. Nella preparazione di una guerra nulla è lasciato al caso. Al pari dei migliori eventi mediatici, di quelle cerimonie con cui i media riscrivono il dispiegarsi della Storia, tutto viene allestito dagli strateghi e dai militari come una grande diretta…”[2]
Nel secondo capitolo, Come cambia l’arte della guerra Tra air power, asimmetrie e soldati robot l’autrice indaga i principali cambiamenti tecnologici che hanno comportato un conseguente cambiamento nelle cose militari: la rapidità degli spostamenti via aria, l’integrazione sempre più capillare dei sistemi di puntamento delle armi con i programmi satellitari, l’efficienza sempre maggiore della diffusione delle informazioni all’interno delle attività militari.
Nel terzo capitolo, Come cambia il racconto della guerra War (and) television, viene narrata la storia dell’integrazione dei servizi mediatici, in particolare dei sistemi audiovisivi, con l’attività bellica. Oliva si intrattiene in particolare su alcuni conflitti particolarmente rilevanti in questo senso: la guerra in Vietnam, l’incursione militare americana su Grenada, le Falkland-Malvine, Panama, la guerra del Golfo del 1991. L’analisi si concentra in particolare sui temi che si ritroveranno poi in comune con l’inscenamento mediatico della guerra dell’Iraq 2003. In questo senso, da un primo momento in cui i media hanno realmente la possibilità di accedere ai campi di battaglia, anche senza un consenso doxastico da parte del sistema militare (guerra del Vietnam), si passa ad un secondo momento in cui i media vengono tenuti il più possibile da parte (Grenada) per poi venire integrati già all’interno della forza combattente o di una sua parte (guerra del Golfo del 1991). Oliva parla anche dei conflitti balcanici, i quali hanno aggiunto all’informazione un sistema di rappresentazioni bipolare (buoni/cattivi) molto fruttuoso per creare un pathos nell’opinione pubblica, possibilmente manovrata proprio da questa manipolazione della realtà: la verità non dovrebbe caratterizzarsi né buona né cattiva in sé e di per sé, questa la tesi implicita. Per tanto, presentare la realtà come bipolare in questo senso, significa già manomettere l’informazione in modo rilevante.
Il quarto capitolo, Operation Iraqi freedom Fighting fast and fighting light, analizza il caso più recente di guerra a sfondo mediatico (definizione nostra), vale a dire del conflitto in cui il ruolo dei media non soltanto viene gestito in maniera razionale, per così dire. Ma viene direttamente integrato all’interno del programma militare in modo da garantire la massima copertura sulle operazioni militari, da un lato, e in modo da fornire le sole informazioni politicamente sfruttabili propagandisticamente, una volta passate attraverso la composizione standardizzata dell’informazione ormai in uso nei media (specie quelli a informazione ciclica).
Il quinto capitolo, L’in-visibilità totale, analizza il circolo vizioso già precedentemente accennato, cioè il paradosso complessivo di un’informazione così piena e capillare e al contempo così vuota e incapace di spiegare alcun che di rilevante dell’attività militare. L’ultimo capitolo è dedicato alle conclusioni.
Il libro Fuori fuoco L’arte della guerra e il suo racconto intende fornire le informazioni necessarie per spiegare il circolo vizioso di cui abbiamo parlato sopra. Sebbene l’opera complessivamente senza dubbio riesce a trattare del fenomeno e a darne almeno una parziale spiegazione, ci sono alcuni punti su cui, tuttavia, si sarebbe potuto argomentare maggiormente.
Prima di tutto, non è chiaro il ruolo del giornalista all’interno delle attività militari. Egli deve essere testimone oculare? Chiaramente. Ma ci sono molti modi di essere testimoni oculari. In nessuna parte del libro vien chiarificato il ruolo del reporter militare. Vien semplicemente dato per scontato che costui debba riportare almeno tutte le verità in cui egli crede. Si intravede nella natura delle argomentazioni, ma ci sono molti modi di riportare verità. Ad esempio, un giornalista potrebbe descrivere minuziosamente tutti i solchi degli scarponi dei soldati della coalizione angoamericana: sarebbe utile? No, ovviamente. Sarebbe vero, però. Se, allora, si danno vari tipi di ʽveritàʼ, cioè alcune rilevanti e alcune irrilevanti, si deve caratterizzare la natura di questa rilevanza. Questo, poi, diventa particolarmente problematico se si considera che molto spesso i giornalisti sono sprovvisti dei mezzi che gli servono per capire la guerra in atto: chi legge gli articoli sui quotidiani sulla guerra in Siria, si rende subito conto che in generale la storia del medio oriente è pressoché sconosciuta. Quindi, bisognerebbe anche introdurre una buona caratterizzazione di un giornalista in grado di riportare effettivamente le informazioni salienti, importanti, e tralasciare le altre. Non si può affatto dare per scontato tutto questo, laddove sin da Platone si condanna l’opinione, specialmente per quanto riguarda le rappresentazioni visive, che è proprio ciò di cui il saggio parla maggiormente. D’altra parte, per capire la seconda guerra mondiale non è certo sufficiente vedersi tutti i filmati che sono stati prodotti nel periodo bellico. Si avrebbe probabilmente lo stesso effetto di smarrimento che a guardare uno degli ultimi programmi televisivi a ciclo informativo continuo.
Un secondo motivo di perplessità potrebbe essere dovuto al fatto che l’opinione pubblica mondiale sia ipso facto l’opinione pubblica degli USA. Questo è chiaramente errato. Prima di tutto non vale per almeno un quarto della popolazione mondiale (il popolo cinese), cifra non trascurabile. Ma non vale neanche per quei paesi arabi che seguono le emittenti del Qatar, visto gli sconcertanti risultati recenti e lontani che non vogliamo neppure commentare. Non soltanto l’opinione USA non è quella che batte la sola moneta corrente, ma è da discutere quanto questa possa essere tendenziosa, se almeno si paragona la CNN alle emittenti arabe, russe e cinesi. Se la CNN non sarà paladina della democrazia informativa, ci vien da chiederci quanto le emittenti gestite da un solo partito, da un solo monarca o piuttosto da un dittatore, possano invece conservare più verità della CNN. Il punto è importante perché il lettore del libro può confondere la sola analisi dei media occidentali con l’analisi dei media tout court. Il che non può essere fatto apoditticamente, ma va dimostrato: se è vero che le emittenti degli Stati Uniti impongono una sola versione dei fatti anche per le emittenti dei paesi rivali, allora ciò va argomentato con molti dettagli, a meno di risultare del tutto unilaterali.
Rispetto a questo secondo punto, ne dobbiamo necessariamente avanzare un terzo. Il saggio lascia intendere che in qualche momento della storia si sia data davvero la possibilità ai reporter di conoscere la realtà dei fatti militari, così come si sono presentati. Ciò è evidentemente molto discutibile. E’ vero che vien detto nel saggio proprio che il ruolo del giornalista è sempre stato difficoltoso, ma non che sia stato impossibile. Non sembra essere del tutto chiaro, laddove ci sono stati conflitti di cui molti giornalisti non si sono mai neppure occupati: o perché non esistevano o perché non interessavano a nessuno.
In quarto luogo, vien difficile accettare un’altra tesi difesa nel saggio:
L’ultima di queste è, a seconda delle definizioni, “la guerra totale permanente” – formula banale ma che nota una dimensione pervasiva, continuamente protratta nel tempo e nello spazio – che apre uno scenario in cui tutti i termini e le distinzioni tradizionali sembrano girare a vuoto (dalla cancellazione dei limiti fra pace e guerra, interno e esterno, civile e militare, stati in grado di “dichiarare la guerra” e stati che possono “firmare la pace”, alla redistribuzione al di là di ogni dimensione stabile dell’asse amico/nemico).[3]
Vegezio disse nel suo Epitoma rei militari: se vuoi la pace, prepara la guerra. Gli storici romani hanno difficoltà a comprendere la pace. Non ne parlano quasi. Perché quasi non ce n’è stata. Durante la caduta dell’impero romano l’instabilità politica e sociale è rimasta addirittura nella pur scadente memoria storica delle genti europee. Instabilità politica e sociale che si traduce fondamentalmente in vari gradi di violenza. Il monopolio stesso della violenza non è mai stato garantito in modo sufficiente da nessuno stato prima del XIX secolo. Durante poi il luminoso XVIII si sono combattute in successione una quantità di guerre che non possiamo qui riportare. Ma basta considerare che nella mitologia dei popoli più diversi la guerra (o il suo simbolo, il guerriero) faccia capolino. La guerra nel mondo romano, medioevale e moderno non è semplicemente normale. E’ intrinsecamente parte della vita. In genere o si è soldati o si subiscono le angherie dei soldati. Il valore della pace è una idea recente, una moda che ha anche male attecchito: il fatto che alcuni, compreso l’autore di questa recensione, possa essere rammaricato di questo fatto, ben poco cambia la sostanza delle cose. Basta considerare il peso, ancora insufficiente, della proposta kantiana per comprendere quanto poco i popoli riconoscano nella pace qualcosa di sensato. Gli Stati Uniti, così spesso colpevolizzati (anche a ragione, per carità) sono solo gli ultimi. E tra i tanti, sono quelli che con più riluttanza hanno combattuto guerre: basti considerare che né nella prima né nella seconda guerra mondiale avevano, inizialmente, un buon arsenale e non volevano neppure intromettersi negli ʽaffari europeiʼ. Le cose sono cambiate, ma questo non bisognerebbe dimenticarlo. Anche perché, se è vero che le loro scuse valgono quanto quelle degli altri, che la loro violazione dei diritti umani vale come per gli altri, è anche vero che tra tutte le menzogne inventate, quelle americane sono più gradevoli rispetto all’imperialismo dichiarato dell’impero inglese, francese, italiano e via dicendo. Per essere un imperialismo, lo è, ma in modo triste. Per così dire: ci provano ad inventare scuse plausibili.
Ci sono poi alcuni punti in cui la storia sembra venire considerata in modo troppo locale. Ad esempio:
Le “vecchie guerre”, essendo “statalizzate”, davano luogo ad una sorta di sistema di equilibro nel quale solo gli Stati sovrani erano soggetti competenti a dichiarare e a condurre la guerra così come a stipulare la pace: erano simmetriche. Rendevano perciò possibile, da un lato, un riconoscimento giuridico-formale della guerra, e, dall’altro, il tramonto della “guerra giusta”.[4]
Le guerre perpetrate dai coloni inglesi contro gli indiani erano di questo genere? Le guerre coloniali in cui l’iniziativa non era presa direttamente dal governo ma dalle società commerciali (ad esempio le compagnie delle indie orientali) prevedevano questa simmetria? Le crociate non possono essere definite “guerre combattute tra Stati sovrani” perché gli “stati sovrani” sono molto più recenti. Sono molto più recenti di gran parte delle guerre, giacché il fenomeno dello stato-nazione fondato sulle costituzioni è il lento risultato di ben quattro secoli di attività politiche e rivoluzionarie (XVI-XIX). In secondo luogo, c’è chi ha negato esplicitamente il fatto che le guerre possano essere definite in alcun modo legali: prima Kant (Per la pace perpetua), poi Bobbio (Il problema della guerra e le vie della pace) mostrano in modo chiaro in che da un punto di vista legale la guerra non può essere dichiarata “giusta”. Per tanto, non si vede come il concetto di guerra giusta, che poi non si è ancora capito quale o cosa si debba intendere, possa tramontare non essendo mai sorto. O, perlomeno, non si capisce in che modo le recenti guerre degli Stati Uniti possano essere più ingiuste delle altre solamente perché vorrebbero rivolgersi non a stati ma a gruppi sociali intrastatali. Parrebbero, perlomeno, ingiuste quanto tutte le altre se non fosse che oggi, appunto, disponiamo di un teorico arbitro internazionale (ONU) che non prevede guerre giuste se non in taluni casi dal punto di vista della difesa.
In fine, sembra strano lasciare intendere, forse, una critica all’idea che la guerra debba essere “rapida ed indolore”: “E il cerchio si chiude. La guerra deve essere rapida e indolore. Fast and light. Perché conviene agli strateghi e conviene ai media […]. C’è questa coincidenza di intenti, di modalità e di esigenze dietro alla scelta di dare massimo risalto a conflitti armati nei quali la vittoria è sicura e dove c’è, o sembrerebbe esserci, la garanzia di una guerra lineare, breve – chirurgica -, facile da seguire come uno spettacolo televisivo […]”.[5] Questa idea, cioè che la guerra deve cercare di paralizzare il nemico, non è più così recente, anche se non sarà mai sufficientemente in auge. Ma già nella prima e poi nella seconda guerra mondiale si vagheggiava la tanto amata blitzkrieg.
Fu teorizzata per la prima volta da Basil Liddell Hart, uno dei più grandi strateghi del XX secolo. Egli adduceva, tra le altre, la motivazione essenziale che risparmiare vite umane, anche quelle del nemico, è meglio che distruggere prima di tutto perché il nemico di oggi sarà il partner commerciale e militare di domani, e in secondo luogo perché la distruzione toglie almeno indirettamente ricchezza anche a noi (tutto ciò in Paride o il futuro della guerra). Ed infine, aggiungeva che siccome l’animo umano è incorreggibile, se proprio si deve combattere, almeno lo si faccia nel modo più indolore possibile perché è conveniente e la convenienza è comprensibile anche all’egoismo più gretto. Anzi, soprattutto a questo.
Vista la potenza distruttiva potenziale degli attuali arsenali militari più sviluppati (non solo quelli USA ma anche GB, Francia, Russia, Cina, Israele, Turchia…) sembra che lo stile Fast and light sia da preferire ad una guerra più tradizionale nella visione immaginaria tratta dai film della seconda guerra mondiale o sulle guerre napoleoniche piuttosto che romane (non certo dai film sulla guerra del Vietnam che hanno segnato due generazioni contrarie almeno prima facie alla guerra). In queste rappresentazioni si fronteggiano sempre due eserciti più o meno di uguale grandezza, uguale armamento che coraggiosamente si fronteggiano a viso aperto e ad armi pari. Questo è chiaramente una stilizzazione di un duello di boxe. Questo è quello che ha provocato quindici milioni di morti nella prima guerra mondiale, a detta di Liddell Hart e non solo sua.
Dunque, se proprio si deve fare qualcosa di così umanamente osceno come la guerra, forse è meglio farla in modo che muoia il minor numero di persone. Altrimenti si cade nel paradosso di accettare una guerra più onorevole dal punto di vista rappresentativo (armi pari, informazioni pari, colpi sopra la cintura e vietate le mosse irregolari) che conduce alla distruzione di un intero paese. Con il che, nel saggio non si prende posizione per una guerra di questo secondo genere. Lo diciamo esplicitamente. Ma talvolta, a leggere e rileggere questa critica al Fast and Light, probabilmente indotta dal fatto che è ancora una volta una menzogna, una immagine (e però questo davvero andrebbe dimostrato, dimostrato attraverso dati comparativi che mostrino come la guerra Fast and Light si dimostri uguale alle Slow and Heavy) presentata nei media, sembra lasciare intendere che questa sia una metodologia di principio sbagliata. Lo ribadiamo. E’ una sensazione, non vien detto nel libro. Ma è giusto riportare quella che è una sensazione, laddove probabilmente questa può mettere in luce un tipo di argomento che può essere fuorviante.
Tutto considerato, comunque, nonostante queste critiche che ci paiono doverose per chi cerca di vedere fino in fondo la natura argomentativa di un saggio, rimane il fatto che l’autrice riesce a mostrare bene il meccanismo perverso attraverso cui i media ci omaggiano di finzioni programmate e per quale ragione questo meccanismo sia venuto ad essere. Informazioni non confermate, non smentite, credenze sparse senza essere prima verificate: tutto questo ormai fa parte della normalità. Come anche fa parte della normalità (e non certo in senso di “buona normalità”) l’usuale tintura a colori bianco e neri delle posizioni dei vari agenti politici. Non soltanto la destrutturazione dell’informazione passa attraverso un meccanismo che tende a semplificare l’informazione stessa, appiattirla e caratterizzarla secondo opinioni politiche tendenziose, ma è anche vero, come ben viene spiegato, che è impossibile farsi un’idea di ciò che accade. Anche volendo, anche guardandosi tutti i telegiornali possibili. C’è da dire che esistono diversi sistemi per scoprire la verità, nonostante tutto: riviste specializzate in warfare, riviste specializzate in geopolitica, blog dedicati. Certo, si suppone che il grande pubblico non abbia accesso a simili fonti, anche se pubbliche. Certo è che il pubblico ha la sua quota di responsabilità nel fatto che i media siano quello che siano. Perché si rivolgono ad un pubblico che non è minimamente esigente, visto che continuano a vivere. Un pubblico che non ha a cuore la verità e, molto spesso, la vita umana del vicino. Lontana anni luce nella mente, a fianco a lui nello spazio, si tratta di problemi che non possono indugiare dentro una vita già troppo piena di funeste informazioni.
Ciò detto, dunque, ci sentiamo caldamente di consigliare questo libro a tutti quelli che vogliano farsi un’idea più precisa di quanto accade oggigiorno all’interno della produzione mediatica sulla guerra.
Maddalena Oliva
Fuori fuoco L’arte della guerra e il suo racconto
Odoya
Pag.: 188.
Euro: 16,00.
[1] Oliva (2008), p. 19.
[2] Ivi., Cit., p. 31.
[3] Oliva (2008), p. 19.
[4] Ivi., Cit., p. 21.
[5] Ivi., Cit., p. 33.




Be First to Comment