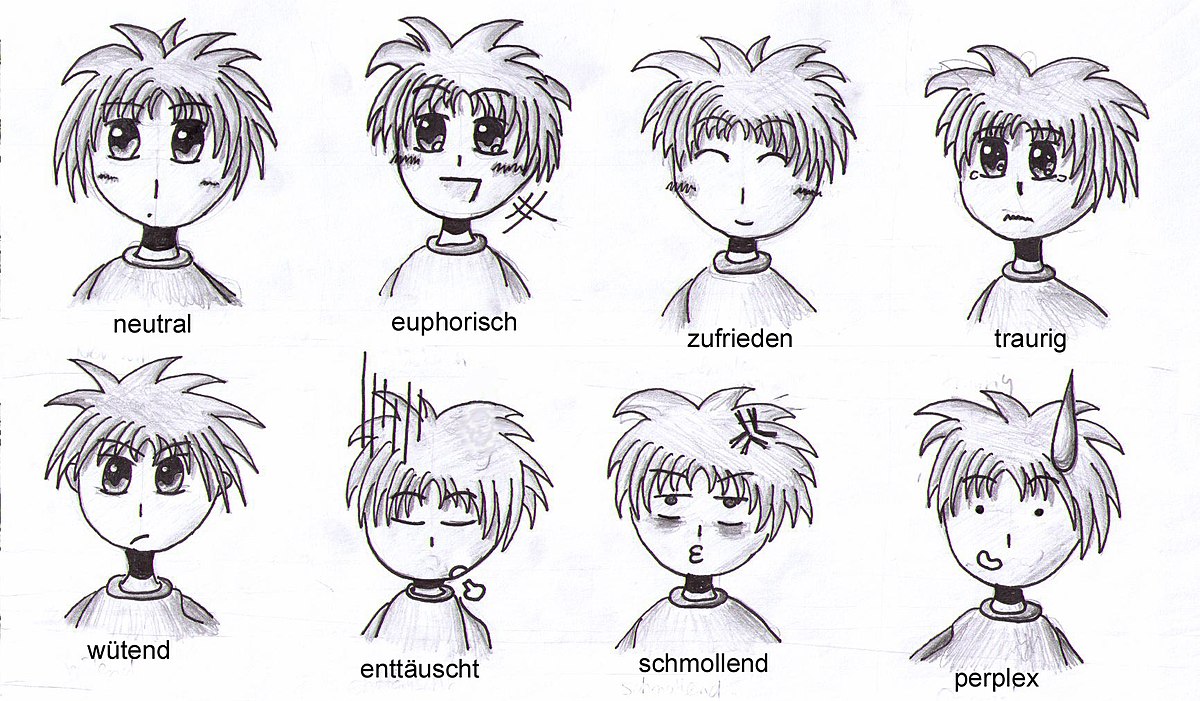
Iscriviti alla Newsletter!
Introduzione
La storia della filosofia morale è senz’altro molto lunga e complessa, dunque ogni tentativo di ridurla a schema evolutivo secondo categorie dal potenziale dicotomico come quelle di ragione ed emozione non può che portarci ad una conoscenza parziale della complessità che compone il percorso della filosofia morale dal suo nascere ad oggi. La riduzione è nondimeno necessaria, e le categorie riducenti possono senz’altro avere due vantaggi: primo, agevolano la nostra comprensione della storia, altrimenti difficilmente raggiungibile; secondo, permettono alle volte, quando le categorie sono inusuali rispetto alla norma, di scoprire fatti nuovi o portare alla luce fenomeni prima all’oscuro, attraverso il darsi di nuove interpretazioni. Tolto l’ausilio della semplificazione e della categoria rimaniamo in preda al caos e all’indeterminazione più assoluti, i quali non permettono la nostra comprensione dei fatti. Il farsi carico di questa necessità però non implica sfigurare i fatti della storia attraverso le proprie categorie e il proprio metodo di comprensione – nonostante si ammetta questo sia in certa misura necessario o costitutivo al darsi della realtà – ma anzi tendere verso una sempre maggiore aderenza alle vicende storiche del pensiero.
Esaminate le vicende del pensiero filosofico morale, azzardo un’asserzione audace, che cercherò di supportare mostrando l’andamento della storia, interpretata alla luce della risposta che le varie filosofie nel loro susseguirsi hanno dato alla domanda del ruolo relativo di emozione e ragione nel processo di presa di decisione e azione morale. L’asserzione audace è che la storia della filosofia morale occidentale, almeno fino alla modernità, è caratterizzata da un pensiero che enfatizza ed esalta la componente della ragione nel processo di presa di decisione e azione morale, mentre demonizza e scredita la componente emotiva, alla prima opposta. Se la ragione ci mette in contatto con le idee più alte e nobili (es. con la divinità stessa), l’emozione non è che il ricordo nell’uomo della sua animalità. Dove la ragione è l’alta manifestazione dell’anima, l’emozione è la bassa manifestazione del corpo. La ragione favorisce e arricchisce la nostra vita morale, mentre l’emozione per lo più impedisce il suo corretto darsi. La moralità stessa è concepita come un sistema di principi coglibile astrattamente dalla ragione, e le emozioni come motivazioni che possono favorire o sovvertire la nostra decisione razionale, motivazioni che sono però moti (ciechi) non-razionali che tendono a dominarci. Questa tendenza generale della filosofia morale rappresenta per noi il paradigma della tradizione, messo in discussione dalla filosofia sentimentalista del XVIII secolo. A questa discussione del paradigma, o rivoluzione, come più avanti l’ho chiamata, segue la risposta della tradizione, che si compie in Kant. Il pensiero post-kantiano però vede il superamento del paradigma tradizionale, nel solo senso che tendenzialmente l’emozione non è più ignorata come elemento di disturbo o inessenziale alla morale.
La nostra storia non pretende di essere esaustiva di tutto quello che la filosofia morale ha saputo pensare, anche perché da alcune filosofie non è di fatto deducibile una risposta chiara alla nostra domanda.
Vedremo come sia possibile rintracciare, all’interno di un percorso osservato con la lente del rapporto conflittuale tra ragione ed emozione, diversi ed opposti modelli del giudizio morale, i più significativi individuati consistere in quello Humiano e in quello Kantiano, il rapporto tra i quali esemplifica perfettamente la dicotomia tra chi vede nella ragione la componente principale del processo di presa di decisione e azione morale e chi la vede invece nell’emozione.
Inizio con l’affidarmi al commento di una studiosa di notevole autorità e indiscussa competenza: Martha Nussbaum. In Upheavals of Thought, Nussbaum commenta così:
le emozioni […] non possono esser messe da parte facilmente nelle spiegazioni del giudizio etico, come tanto spesso è accaduto nella storia della filosofia. […] le emozioni dovrebbero essere parte fondamentale dell’oggetto della filosofia morale […] non possiamo ignorarle, come tanto spesso ha fatto la filosofia morale. (p. 17-18, corsivo mio)
Le emozioni sono state meno l’oggetto della filosofia morale di quanto lo sia stata la ragione. E questo noi ci proponiamo di mostrarlo.
Prima di procedere è utile fare chiarezza sulla domanda centrale alla quale vogliamo far rispondere le filosofie che intendiamo interrogare. La contrapposizione tra emozione e ragione è diffusa nella vita privata e in quella pubblica, la troviamo nel diritto ad esempio. La troviamo sui giornali, alla televisione, sull’autobus e nelle aule universitarie. Però è una contrapposizione spesso caratterizzata da vaghezza e oscurità. Dal fatto che l’emozione sia contrapposta alla razionalità si deduce che essa sia caratterizzata da irrazionalità. Tuttavia il termine ‘irrazionale’ può essere inteso in più modi. Si può intendere che l’emozione sia qualcosa di non razionale, ovvero di diverso od opposto al ragionamento; si può intendere che l’emozione sia qualcosa che implica un pensiero non corretto. Il pensiero razionale sembra esserci in entrambi i casi, solo che nel secondo caso intrattiene un rapporto di vicinanza conflittuale con l’emozione, e precede l’azione morale, mentre nel primo caso segue l’azione e intrattiene un rapporto più distante con l’emozione, che sembra determinare l’azione in solitudine. Come intendiamo il termine irrazionale inoltre dipende dalla visione normativa che possediamo riguardo al termine razionale. Così scrive Sidgwick a proposito del conflitto tra emozione e ragione:
Suppongo che ciascuno di noi abbia avuto esperienza di ciò che si intende quando si parla di conflitto tra ragione e i desideri non razionali o irrazionali […] i desideri sono irrazionali, in quanto ci spingono a volizioni che sono opposte ai nostri giudizi meditativi. […] Altre volte, spesso, i desideri irrazionali prendono consistenza nelle azioni volontarie senza che prima si sia giudicato se tali azioni fossero giuste o ingiuste […] in tali casi sembra sia più appropriato dire che tali desideri sono non-razionali, invece che irrazionali. (Metodi, p. 63-64)
Noto subito che per i nostri scopi non è necessario fissare un significato univoco al termine irrazionale. Una stessa teoria può attraversare trasversalmente nelle sue manifestazioni filosofiche particolari la distinzione tra non-razionale e irrazionale, e non è affatto scontato riuscire a disporre le categorie della filosofia morale in armonia con la distinzione tra emozione non-razionale/emozione irrazionale. Sembra dunque più appropriato valutare caso per caso la particolare filosofia, così valutandola nel suo complesso, analizzando d’essa diverse caratteristiche. Queste osservazioni però ci portano ad asserire che, al fine di determinare la risposta della filosofia alla nostra domanda, può essere utile analizzare sia la parte descrittiva sia la parte normativa riguardante la psicologia morale dell’individuo.
Da sempre la filosofia si interroga sulla relazione, nell’uomo, tra emozione e razionalità, tra affetto e ragione, ma è ragionevole aspettarsi ch’ogni filosofia abbia dato una propria caratterizzazione al termine emozione o affetto, e di conseguenza abbia concettualizzato in modo dissimile il rapporto emozione-ragione. Negli ultimi venticinque anni abbiamo assistito in campo scientifico ad una crescita di interesse, da parte di diverse discipline (es. psicologia cognitiva e sociale, economia, neuroscienza), verso il tema del rapporto, nell’uomo, soprattutto relativamente alle proprie decisioni, tra emozione e ragione. L’interesse scientifico verso il tema però non sembra aver portato alla possibilità di contrapporre semplicisticamente le due istanze. Piuttosto sembra necessario, prima di poter comprendere la relazione nell’uomo tra le istanze, assumere una certa concettualizzazione e dell’emozione e della razionalità. Ovvero, è necessario procedere da una definizione (spesso operativa) dell’istanza. Ad esempio, nel momento in cui si studiano gli effetti dell’emozione sul giudizio, sulla decisione e sul comportamento, andrebbero distinti due tipi di fenomeni emotivi: gli stati emotivi la cui fonte di emergenza risiede altrove rispetto all’oggetto del giudizio o della decisione, e gli stati emotivi la cui fonte di emergenza risiede nell’oggetto del giudizio o della decisione (Pham, 2007; Bodenhausen, 1993). Ma anche il tipo di razionalità intesa andrebbe specificato. Ad esempio si possono distinguere tre concettualizzazioni di razionalità: la persona è razionale quando le sue credenze, i suoi giudizi, le sue scelte e le sue azioni rispettano certi standard logici; la persona è razionale quando le sue decisioni e le sue azioni sono coerenti con i suoi obbiettivi e i suoi interessi personali; infine, certi comportamenti sono razionali non perché sono logicamente consistenti o perché servono l’interesse personale dell’agente, ma perché soddisfano obbiettivi posti dalla società, o perché realizzano alti valori morali, o ancora perché sono il mezzo attraverso cui l’evoluzione può procedere[1] (Pham, 2007). È evidente dunque che definire un’emozione come razionale o irrazionale non potrà essere fatto finché non si specifichi quale particolare concettualizzazione della razionalità si sta assumendo.
Il termine emozione[2] è ambiguo non solo quando contrapposto al termine razionale, ma anche in se stesso. Meglio, è ambiguo quando contrapposto al termine razionale, vago in se stesso. Infatti esso designa una vasta e diversificata al suo interno classe di emozioni, alcune delle quali classificabili come negative, altre come positive, alcune come solitamente più irrazionali, altre come solitamente meno irrazionali[3]. Nell’analizzare una filosofia si terrà conto per lo più della sua opinione generale sull’emozione, piuttosto che della sua opinione sulle singole emozioni.
A noi interessa sapere qual’é il ruolo attribuito all’emozione, comunque intesa[4], nel processo di presa di decisione e azione morale. Più precisamente a noi interessa sapere quale è, secondo le varie filosofie, la componente principale che determina o che dovrebbe determinare il giudizio e l’azione morale; vogliamo comprendere da una parte la psicologia morale deducibile dalle descrizioni delle filosofie, o altrimenti compatibile con queste descrizioni, dall’altra qual’é il giudizio attribuito a questa psicologia e dunque quali caratteristiche di questa sono desiderate dalle filosofie.[5] Non sarà inutile allora comprendere come l’emozione (o il ragionamento) è valutato normativamente, i.e. se l’emozione (o il ragionamento) è oggetto, da parte della filosofia, di un giudizio di approvazione, di disapprovazione, oppure di una valutazione neutra, semplicemente descrittiva.
Così ci interessa capire se per lo più sono le emozioni ad influenzare il ragionamento e l’azione morale oppure se avvenga il contrario; ci interessa capire chi, secondo la particolare filosofia, vince su chi, chi è lo schiavo di chi, i.e. se sia per lo più la ragione a determinare l’emozione o l’emozione a determinare la ragione. Chi di fatto segue chi, tra ragione e passione? E chi deve seguire chi, tra ragione e passione? Tutti gli elementi compongono il quadro d’insieme. Ponendo la nostra domanda dunque intendiamo interrogare su quale sia l’atteggiamento generale di una filosofia nei confronti del ruolo dell’emozione e del ragionamento nel processo di presa di decisione e azione morale.
La risposta della filosofia antica e medievale alla domanda è che la ragione è la componente più importante del processo di presa di decisione e azione morale. L’emozione è per lo più disprezzata. Con la modernità assistiamo allo scontro tra morale del sentimento e morale della ragione[6], che è poi lo scontro tra il sentimentalismo scozzese che tenta di rovesciare la tendenza della tradizione, e Kant, reazione e culmine della tradizione. La filosofia che segue vede per lo più la vittoria della risposta per cui l’emozione è una componente importante del processo di presa di decisione e azione morale; l’istanza tradizionale sembra essere stata superata. Questo è detto in maniera molto schematica e imprecisa. Vediamo dunque, seppur in breve, le realtà che si nascondono dietro e vengono semplificate da questo schema.
1. La filosofia antica
Se la morale è certo qualcosa che caratterizza qualsiasi società umana di oggi e di ieri, volendo restringere il campo d’indagine alla storia dell’occidente, e all’analisi della teoria etica (e non semplicemente dei codici morali vigenti in una determinata società), possiamo cominciare la nostra micro-storia dal IV secolo ac. greco: Socrate, Platone, e soprattutto Aristotele.
Come – relativamente alla cultura ove queste filosofie sono radicate – non tutti gli uomini sono soggetti morali, non tutte le parti dell’uomo sono destinate all’etica: solo l’anima, e la parte razionale di questa, è propriamente ciò che fa del soggetto un soggetto morale. Le passioni, considerate alla stregua di malattie di anima e corpo, sono invece inessenziali, o essenziali nella misura in cui sono schiave ubbidienti della ragione.
Il pensiero dell’anima è già stato introdotto, intorno al VI secolo, attraverso orientamenti religiosi e in senso lato morali, quali il culto di Dioniso, l’orfismo e il pitagorismo. L’anima è per sua natura qualcosa che tende a portare l’uomo oltre se stesso, verso una condizione immortale di purezza, del tutto estranea alla dimensione del corpo, che così le viene spesso contrapposto. L’anima è la sola protagonista dell’avventura salvifica dell’uomo, pensata dai movimenti religiosi. Così, il rapporto tra anima e corpo è un rapporto fra puro e impuro, dove l’impuro è tale proprio perché si rapporta con il puro. Moralizzando questo rapporto possiamo dire che l’anima è come sepolta nel corpo, sua tomba; e la sepoltura è castigo che sanziona qualche colpa commessa dall’anima. E si comprende il pensiero ascetico per cui si può cercare già in vita di purificare l’anima dal corpo, così che questa già possa tendere verso il divino, appunto facendo pratica d’ascesi corporea. Il pensiero dell’anima funge da premessa e sfondo alla visione tendenzialmente negativa dell’emozione da parte del pensiero filosofico antico.
1.1 Socrate
È con Socrate che il pensiero dell’anima si emancipa dal contesto religioso orfico e pitagorico, per diventare protagonista del discorso morale filosofico, subendo così a pieno un processo di individualizzazione e moralizzazione. Nel Fedone leggiamo di Socrate che dialoga con Simmia; Socrate dice piuttosto esplicitamente che
fino a quando abbiamo il corpo e la nostra anima è mescolata e confusa con un male di tal natura, noi non saremo mai capaci di conquistare compiutamente quello che desideriamo e che diciamo essere la verità (66b, corsivo mio).
E più avanti:
In questo tempo che siamo in vita, tanto più saremo prossimi al conoscere, quanto meno avremo rapporti col corpo […] non ci lasceremo contaminare dalla natura propria del corpo, e ci terremo puri e lontani da esso finché non venga il dio di sua volontà a liberarcene del tutto (67a).
L’uomo, nella sua essenza morale, non è altro che anima. La virtù è propriamente la conoscenza, la capacità razionale di conoscere il bene e il male; il vizio è dunque ridotto a mancanza di conoscenza, ovvero ignoranza. Dove il corpo e le emozioni (che evidentemente da questo scaturiscono) sopraffanno l’uomo e la sua anima, non v’è che ignoranza. L’anima è razionalità, e l’uomo saggio o compiuto rifugge l’irrazionale, ovvero il corpo e allora le passioni. Da questi elementi deduciamo che per Socrate l’elemento principalmente coinvolto e da coinvolgere nel processo di presa di decisione e azione morale è senz’altro la ragione, o meglio la retta ragione. E così sarà per circa due millenni: questa è la determinazione iniziale del paradigma tradizionale.
Ma prima di Socrate, anche i presocratici pongono come elemento nobile e primo la ragione contro l’emozione nella morale. In Eraclito e Parmenide però l’anima non è quella pura di Socrate, essendo permeabile e contrastabile dalle pulsioni passionali che tendono al soddisfacimento del desiderio corporeo. Questo spiega perché questi filosofi pongono come soggetto del percorso di salvezza non tanto l’anima quanto il logos (nel caso di Eraclito) e il nous (nel caso di Parmenide). Logos e nous rappresentano le istanze della ragione, così che, per la questione che qui ci riguarda, si può pensare il pensiero presocratico senza soluzione di continuità con quello di Socrate: per entrambi è la ragione che si segue e va seguita nelle questioni di pertinenza morale.
1.2 Platone
Per comprendere il pensiero morale di Platone su ragione e passione è necessario rifarsi a quanto esposto nella Repubblica. Platone è ormai lontano dalla visione socratica di un’anima pura: questa è già scissa in diverse istanze motivazionali, i.e. non tutto è ragione nell’anima, sede del soggetto morale. Nel IV libro l’anima è concepita come composta da tre elementi: l’elemento razionale (logistikon), l’elemento irrazionale e appetitivo (epithymetikon), l’elemento dell’animo, che ci rende animosi (thymos). L’anima dunque non è più un’istanza pura contrapposta al corpo, ma le istanze corporee ora la inquinano. Questo implica una speranza di comunicabilità o di rapporto amichevole tra la parte razionale e la parte irrazionale del soggetto. Le due parti non sono più separate dal fatto di essere confinate l’una nell’immortalità l’altra nella mortalità, – a cui segue dopo la moralizzazione del rapporto alto-basso, la malvagità della dimensione corporea e dell’irrazionalità – dunque possono sperare in un dialogo tra loro. Questo però non porta ad una confusa gerarchia delle istanze: è la ragione che governa e deve governare la parte irrazionale. Quest’ultima parte – tornando alla scissione dell’anima operata da Platone – è composta da due elementi separati: l’elemento desiderante e l’elemento emotivo dello thymos, che funge da intermedio tra ragione e desiderio. Questo elemento irrazionale dell’anima (i.e. il thymos), nonostante la sua irrazionalità, può essere un valido alleato al servizio dell’istanza razionale. Infatti l’elemento animoso è giudicato migliore dell’elemento desiderante. E poiché l’elemento razionale di per sé, nonostante sia dotato di capacità governative e di guida, è incapace di muovere l’individuo all’azione, l’elemento animoso è la componente necessaria a fungere da energia sfruttabile e dirigibile dalla parte razionale dell’anima. Nel Fedro questi aspetti sono espressi molto bene attraverso la metafora dell’anima come biga. L’auriga è la parte razionale dell’anima, i cavalli sono il desiderio e l’animosità. È in potere dell’auriga guidare il carro, ma non muoverlo, per fare ciò ha bisogno di servirsi dei cavalli che prima deve comunque sottomettere. Nel IX libro della Repubblica abbiamo un’altra metafora (più) esplicativa del pensiero di Platone. In ogni anima v’è un uomo che rappresenta la sede vera e propria del soggetto morale, la sua parte razionale; un leone, che rappresenta l’elemento emotivo animoso; un mostro dalle molte teste, che rappresenta la congerie emotiva e irrazionale dei desideri. L’uomo può e deve allearsi con il leone per combattere il mostro pluricefalo. Il leone deve essere educato e addomesticato dall’uomo per domare la bestia pluricefala. Il principio della ragione deve così governare le altre istanze per tendere alla conoscenza, ovvero alla virtù della sapienza. Nel Timeo troviamo indicata la sede somatica dei tre elementi: l’elemento razionale è posto nel cervello, l’elemento animoso è posto presso il cuore, l’elemento desiderante è posto nelle viscere e negli organi sessuali. Puntualizzo che ogni parte dell’anima ha i suoi desideri, anche la parte razionale, che tende alla conoscenza e dunque si realizza nella virtù della sapienza. I desideri della parte propriamente desiderante sono invece violenti insaziabili e degradanti, per questo vengono visti nascere dalle viscere e dagli organi sessuali; la virtù che caratterizza questa parte è la temperanza, ovvero la sottomissione al governo della ragione. Nelle Leggi Platone presenta una visione diversa dell’anima, divisa non più in tre parti ma in due: l’elemento animoso è omologato all’elemento desiderante come irrazionale, entrambi gli elementi sono nemici della ragione, che ora perde il suo alleato. In questo modo Platone semplifica la contrapposizione interna all’anima che vede ora la parte razionale opporsi direttamente alla parte irrazionale ed emotiva. Un modello simile sarà ripreso dagli stoici, ma la tradizione aristotelica e la stessa platonica invece riprenderanno un modello per cui la parte animosa è educabile e così alleabile alla ragione contro la parte irrazionale più bassamente desiderante. Si può dire dunque che la posizione caratterizzante Platone sia quella dell’anima tripartita piuttosto che quella dell’anima bipartita, che caratterizza meglio la posizione stoica.
Nella visione propria di Platone si ha giustizia, e così la salute dell’anima, quando l’anima è governata per intero dalla ragione, che per muovere l’uomo verso la virtù si è alleata con il thymos, e tiene sotto controllo l’elemento desiderante temperato. La salute dell’anima dipende dal fatto che ogni elemento dell’anima svolge il proprio ruolo in ‘armoniosa concordia’ con gli altri elementi: nell’uomo sano e giusto governa la parte razionale dell’anima, a seguito di un lavoro che l’uomo stesso ha compiuto su di sé al fine di assicurare nell’anima il dominio assoluto della ragione sulle passioni e sui desideri. Traendo le conclusioni, se pur Platone rispetto a Socrate avvicina nella sua visione dell’uomo la parte corporea irrazionale emotiva a quella dell’anima razionale, rimane nella sua filosofia la svalorizzazione della parte emotiva irrazionale e corporea di fronte a quella razionale. La passione è e deve essere schiava della ragione, anche se può in certi casi non esserlo.
1.3 Aristotele
Con l’Etica Nicomachea di Aristotele si è al centro e al culmine del pensiero etico greco. Diciamo subito che anche in Aristotele abbiamo una decisa preferenza per la componente razionale a discapito di quella emotiva, e che il pensiero di Aristotele insieme a quello di Platone e ovviamente a quello di Socrate è categorizzabile come pensiero della retta ragione. Ma poiché Aristotele è forse il primo grande filosofo analitico, comunque rigoroso e puntuale nelle sue distinzioni concettuali, non è semplice ed è invece pericoloso ridurre il suo pensiero ad uno schema interpretativo riduttivo: non resta che vederlo, per le parti che ci interessano, in maniera sufficientemente esaustiva riassunto in qualche nota.
Nel I libro dell’Etica Nicomachea Aristotele afferma che ‘l’opera propria dell’uomo è l’attività dell’anima secondo ragione’; la felicità stessa risiede in un certo tipo di vita attiva secondo virtù della parte razionale dell’anima. Sempre nel I libro troviamo parte del modello dell’anima proposto da Aristotele. Secondo lo Stagirita una parte dell’anima è irrazionale e un’altra è razionale. La parte irrazionale si divide a sua volta in due parti: la prima, che è condivisa con gli esseri vegetali, è la causa della nutrizione e della crescita (questa parte dell’anima non è specifica dell’uomo, essendo infatti condivisa con i vegetali, tanto che pare agire per lo più durante il sonno, e comunque non è da prendere in considerazione quando si voglia discutere di ciò che permette nell’uomo l’agire virtuoso); la seconda, seppur irrazionale, sembra invece partecipare della ragione. Questa parte intrattiene un rapporto di contrapposizione e resistenza con la ragione quando l’uomo che fatica a dominare se stesso non controlla i propri desideri, i quali costituiscono appunto la parte irrazionale della sua anima che si contrappone alla ragione; partecipa invece della ragione quando l’uomo che domina se stesso controlla i propri desideri, che appunto obbediscono alla ragione. Vi sono dunque due parti irrazionali (alogon) nell’anima: l’una (la parte vegetativa) non è in rapporto con la ragione, l’altra (la parte desiderante) partecipa della ragione, in quanto le obbedisce. La parte vegetativa non è concettualizzata come contrapposta od ostile all’istanza razionale, essendone del tutto estranea. La ‘parte impetuosa e in generale desiderante’ (o semplicemente: ‘desiderante’) invece è concettualizzata come partecipante del logos, ma non è un’istanza che si contrappone alla ragione con la violenza che troviamo in Platone, piuttosto è per sua natura un’istanza capace di ascoltare e obbedire alla ragione, anche se qualche volta le si può opporre. Questa parte dell’anima razionale è vista come chi obbedisce al padre, dove il padre è la ragione. Il padre, a sua volta, è diviso – nel libro VI – in due parti. Aristotele distingue la parte razionale ‘con cui contempliamo quegli enti, i principi dei quali non ammettono di essere diversamente’, dalla parte razionale ‘con cui consideriamo gli enti che lo ammettono’.
Diciamo che l’una è la parte scientifica e l’altra è la parte calcolatrice, infatti il deliberare e il calcolare sono la stessa cosa, e nessuno delibera su ciò che non può essere diversamente: quindi quella calcolatrice è una certa parte dell’anima razionale. (EN, 1139a; corsivo mio).
Oltre che distinguere tra funzione pratica e funzione teorico-scientifica (preposta alla comprensione del necessario e dell’immutabile) della parte razionale dell’anima, questo brano ci informa del fatto che per Aristotele ‘il deliberare e il calcolare sono la stessa cosa’. Il processo di presa di decisione è un processo razionale che implica un calcolo operato dalla parte razionale pratica dell’anima. La deliberazione non avviene senza ragionamento: ‘chi delibera cerca qualcosa e calcola, e la buona deliberazione è correttezza della deliberazione’.
La virtù ‘è uno stato abituale che produce scelte, e la scelta è un desiderio deliberato’. La scelta è il principio d’azione, e il desiderio e il ragionamento sono i principi della scelta. ‘La scelta è pensiero desiderante o desiderio pensante, e l’uomo è un principio di questa specie’. Non si dà dunque scelta e agire (con successo) in assenza di ragione e in assenza di uno stato abituale del carattere. La scelta è propriamente la causa motrice, mentre l’agire con successo è la causa finale. Desiderio e ragionamento connettono motore e fine. Causa materiale dell’azione sono evidentemente i movimenti fisici del corpo, causa formale dell’azione virtuosa è lo stato abituale del carattere. Si nota che il pensiero da solo non è in grado di muovere nulla, solamente il pensiero pratico, ovvero quello che tende a qualcosa è in grado di muovere, infatti il pensiero pratico è tale proprio perché orienta il desiderio. La virtù dunque non si dà senza saggezza, ma questo non implica che – come pensava Socrate – le virtù siano forme di ragionamento. Il pensiero di Aristotele è che le virtù siano unite a ragionamento. La virtù è uno stato abituale strettamente connesso alla retta ragione. E che si debba agire secondo virtù è opinione comune e indiscutibile. Dunque si deve agire secondo la retta ragione (secondo saggezza, phronesis). Ciò che rende l’uomo virtuoso sono i corretti stati abituali, definiti da Aristotele ‘quelle cose in base alle quali ci atteggiamo bene o male riguardo alle passioni’. Riguardo alle passioni, per agire correttamente, dobbiamo trovare il giusto mezzo, come dobbiamo trovarlo nell’azione. Le passioni di per sé non sono oggetti morali, è piuttosto l’atteggiamento dell’uomo di fronte ad esse che è giudicabile moralmente. La virtù è allora ‘uno stato abituale che produce scelte, consistente in una medietà rispetto a noi, determinato razionalmente, e come verrebbe a determinarlo l’uomo saggio’. Non sempre però è facile determinare la giusta misura delle cose da cui dipende il nostro corretto agire. Vi sono casi particolari e singolari dove il giudizio propriamente spetta alla sensazione. Con l’uso di questo termine – sensazione – però non dobbiamo pensare che Aristotele intendesse affidare all’emozione la conoscenza della giusta scelta da operare in casi singoli difficilmente riducibili a norme di comportamento generali, perché il termine indica non ‘la sensazione che riguarda i sensibili propri, piuttosto quella con la quale percepiamo’ le figure prime della geometria. La sensazione di Aristotele qui è intelletto, non emozione.
Ma sulla teoria dell’azione e della scelta di Aristotele è necessaria una non marginale precisazione. Aristotele, a differenza di Platone e Socrate, non identifica sfera morale e sfera razionale, dal momento che i fini che la scelta razionale e deliberata dell’uomo si propone di raggiungere non sono essi stessi deliberati razionalmente. I fini vengono posti dalla volizione, indipendente dalla deliberazione razionale e dipendente piuttosto dalla parte impetuosa e in generale desiderante dell’anima. Per questo Aristotele pensa che non basti il corretto ragionamento per fare d’un uomo un buon uomo, ma serve anche l’educazione del carattere da parte della società: qui nasce la virtù etica, che sola è in grado di determinare la bontà degli scopi dell’azione. La scelta è definita ‘pensiero desiderativo’ o anche ‘desiderio pensante’, proprio perché il desiderio per realizzare qualcosa deve comunque fare i conti con il calcolo razionale dei mezzi adatti al raggiungimento dello scopo.
Quando Aristotele nel libro III analizza la scelta, egli afferma che chi non si domina agisce per desiderio, e propriamente non sceglie. Solo chi si domina agisce per scelta. In questo modo il desiderio viene ad opporsi alla scelta; e questa per essere tale deve sempre essere unita a ragionamento e pensiero. Ma la teoria dell’azione di Aristotele è più complicata. Deliberazione e scelta hanno lo stesso oggetto, con la differenza però che ciò che è scelto deve essere prima determinato. Ovvero, si sceglie ciò che prima, attraverso la deliberazione, è stato giudicato. L’atto mentale della scelta è operato allora dalla parte direttiva dell’uomo, i.e. la saggezza, unione di desiderio e razionalità calcolatrice, che pone l’oggetto della scelta. Ma c’è un preciso ordine gerarchico tra desiderio e deliberazione razionale: ‘giudicando a partire dalla deliberazione, proviamo desiderio secondo la deliberazione’. Dunque la deliberazione precede la scelta, e la ragione precede l’emozione.
Si ripetono allora le prescrizioni riguardanti i desideri. Questi devono essere:
pochi, misurati e mai in conflitto con la ragione […] come il fanciullo deve vivere secondo le prescrizioni del pedagogo, così deve fare il desiderio rispetto alla ragione.
Questo passo, che si trova in conclusione del III libro, riafferma quale è e deve essere il rapporto tra emozione e ragione. Abbiamo già visto che nel I libro Aristotele afferma che la parte desiderante è come un figliolo che ascolta e obbedisce agli ordini del padre-ragione. Educare il carattere in vista della vita virtuosa e felice significa dunque, in questa prospettiva, condizionare la sfera dei desideri in modo da renderla stabilmente docile e disposta a seguire il comando della ragione. L’individuo è temperante (i.e. la sua parte desiderante è temperata) appunto quando desidera secondo ragione.
Nel libro VII Aristotele distingue tra mancanza di autocontrollo per impetuosità e mancanza di autocontrollo per desiderio. L’impetuosità segue il ragionamento, però fraintendendolo, mentre il desiderio non segue il ragionamento. Qui il testo non è molto chiaro a proposito della distinzione tra desiderio e impetuosità (EN, 1149b). Ma a noi interessa soprattutto ciò che è sotteso alla conclusione di Aristotele: il desiderio è più turpe perché, se quando manca autocontrollo rispetto all’impetuosità comunque si segue (seppur male) il ragionamento, nel caso invece di mancanza di autocontrollo rispetto al desiderio si cede del tutto al desiderio e non al ragionamento. È interessante come questa conclusione sottenda una chiara visione della superiorità del ragionamento sull’emozione. Solo a partire da una tale premessa si può concludere che è più biasimevole la situazione ove manchi il ragionamento rispetto a quella ove il ragionamento rimanga inascoltato. Aristotele, distinguendo fra possedere la conoscenza e tenerla presente in atto, conclude che il saggio non è semplicemente quello che sa, ma quello che sa mettere in pratica. Non basta che vi sia il ragionamento, seppur già il fatto che vi sia è migliore rispetto al fatto che proprio manchi, ma il ragionamento deve essere messo in pratica. La condizione dell’individuo che non si domina è condizione di chi non sa mettere in pratica.
Dal libro IX possiamo trarre un’ultima considerazione. La parte intellettuale dell’anima è detta essere il ‘vero io di ciascuno di noi’:
… si ritiene che ciascuno di noi sia la sua propria parte pensante, o soprattutto questa […] ciascuno di noi è la sua ragione, e si ritiene che siano soprattutto le azioni non disgiunte dalla ragione a essere compiute da noi stessi […] la ragione sceglie sempre quello che è meglio per sé, e l’uomo dabbene dà retta alla ragione. (EN, 1166a-1169a; corsivo mio).
Questa identificazione o riduzione dell’io alla ragione, seppur qui evidente in massima misura, non dà conto dell’effettivo lavoro di Aristotele nel senso di una teoria morale in grado di dar conto dei più diversi aspetti della natura umana, evitando quanto più possibile semplificanti e ingenue contrapposizioni schematiche tra forze. Abbiamo già visto che per Aristotele le passioni non sono in se stesse il male morale, dato che queste si trovano naturalmente (ovvero non per una scelta volontaria dell’uomo) nell’uomo; è cattivo invece il vizio, che consiste nella mancata regolazione e governo delle passioni da parte della ragione. E la ragione non deve tanto sopprimere la passione, quanto farne buon uso: questo è il senso del governo: sottoporre a regola la vita del suddito. Poi nel caso del comportamento morale la regola del governo è la medietà, che però si dà sempre in un contesto specifico, che dunque difficilmente potrà essere compreso sotto le categorie di una norma generale, e piuttosto, allora, la virtù, nel contesto specifico, sarà sforzo da parte della ragione calcolatrice di approssimazione al giusto mezzo. Abbiamo visto anche che la ragione non determina il fine dell’azione morale, essendo questo determinato piuttosto dalla parte desiderante e volitiva dell’uomo, su cui è possibile agire attraverso la formazione del carattere. Nonostante ciò la ragione – come abbiamo mostrato – rimane essere la sola istanza a cui è demandato il ruolo di guida, comando, paternità, e regalità sulla passione.
1.4 lo stoico
La filosofia stoica segna una radicalizzazione nella concezione del rapporto tra ragione e passione, ma questa radicalizzazione presenta un cifra del tutto caratteristica, che deriva paradossalmente dall’aver identificato la passione con la ragione. Leibniz ebbe a dire a proposito degli stoici: ‘nemici simulati della voluttà, nemici reali della ragione’. Il che effettivamente può apparire del tutto sensato per certi aspetti che vedremo, ma io propongo la lettura classica per cui lo stoico è nemico reale della passione e non della ragione, lettura che mi sembra più sensata di quella deducibile dalla citazione. Per lo stoico l’uomo è di fatto servo della passione. Solo il saggio riesce a eludere la servitù alla passione, ma si dà il caso che il saggio sia una figura quanto mai raramente realizzata nel mondo, tanto che gli stoici stessi non si definiscono saggi. Le passioni sono identificate come il nemico dell’uomo, e sono tanto più pericolose in quanto difficilmente governabili. Il primo passo verso la governabilità di queste consiste nel comprenderle. Per questo motivo, nonostante gli stoici abbiano forse la visione più negativa dell’emozione mai avuta in tutta la storia della filosofia, proprio per questo eccesso che li porta ad identificare la passione con la malattia, a cui segue chiaramente una volontà di guarigione, proprio in ragione di questa visione lo stoico elabora una conoscenza approfondita della sfera emotiva, e pone un’attenzione insuperata – nel mondo antico – verso le passioni. Ovvero, all’eccesso di negativizzazione della passione si accompagna quasi necessariamente una forte attenzione per questa.
La filosofia stoica va oltre quella platonica e aristotelica, denunciando come illusione la presunta naturalità e governabilità della parte irrazionale e passionale dell’anima. Lo stoico rinuncia alla contrapposizione, interna all’anima, tra razionale e irrazionale, che per le grandi filosofie di Platone e Aristotele per lo più si sovrappone alla contrapposizione tra ragione e passione; rinuncia a questa contrapposizione per esasperarla. L’anima ridiventa una e razionale, come in Socrate. L’anima è puro logos, ed ad esso non si contrappone nessuna istanza irrazionale. Tre momenti scandiscono l’agire dell’uomo. Il momento della rappresentazione: l’uomo si rappresenta il mondo esteriore attraverso la mediazione della ragione che trasforma la rappresentazione in un’immagine mentale che è esprimibile in forma proposizionale. Infatti il secondo momento è quello dell’assenso: la ragione afferma o nega le proposizioni di cui sopra, dando vita dunque ai giudizi morali sulle cose. Il terzo momento è quello dell’impulso: la ragione genera direttamente l’azione. Incomincia allora a diventare chiaro cos’è la passione secondo lo stoico, in un modello come questo dove non c’è posto che per l’istanza razionale. La passione è un giudizio errato della ragione: è propriamente la perversione della ragione, i.e. la ragione che sbaglia a dare l’assenso alla rappresentazione. Ma questo impulso malato della ragione, in qualche modo la sovverte e va oltre di essa, diventando irrazionalità e innaturalità. È la ragione che si contrappone alla ragione, genera passione e così irragionevolezza. E non si dà allora alcuna passione in assenza della ragione, infatti per lo stoico gli esseri non dotati di ragione come i bambini e gli animali non hanno passioni, ma impulsi, che solo una volta data la comparsa della ragione possono trasformarsi in giudizi di valore e condotte d’azione sbagliate. La moralità è dunque un prodotto che si dà con la comparsa della passione, e questa si dà con la comparsa della ragione. Si può dire allora che è proprio la comparsa della moralità a rendere l’uomo malato: quando la ragione degenera in passione l’uomo diventa schiavo dell’irrazionalità. Possiamo concludere che lo stoicismo presenta una psicologia morale completamente dominata dalla ragione, dove le stesse passioni non sono che un prodotto della ragione: è il pensiero l’elemento centrale e anzi unico della presa di decisione e azione morale.
Quello che abbiamo presentato è lo stoicismo delle origini, quello di Zenone Cleante e Crisippo. Ma vi è anche uno stoicismo tardo. Ad esempio quello di Posidonio. Per il primo stoicismo l’origine delle passioni, ovvero della degenerazione della ragione, non può che essere esterno, e trovarsi nella forza corruttrice di alcune rappresentazioni o nella società che infetta l’individuo con le proprie opinioni errate. Posidonio invece riporta all’interno dell’anima il principio della passione, teorizzando una parte irrazionale contrapposta alla ragione da cui originano le passioni. Questo sembra semplicemente un ritorno alla visione platonico-aristotelica, e un tradimento della posizione originale della Stoa. Seneca ed Epitteto (non Cicerone) invece, pur essendo tardi, non accettano il tradimento di Posidonio, rimanendo fedeli all’assolutismo della ragione.
Se la passione è ingovernabile, l’unica giusta misura da adottare nei suoi confronti è la più estrema: l’eliminazione. Il saggio infatti è colui che è privo di passioni (apathes); è il sano contrapposto al malato. Per Epitteto il dominio (come estirpazione) delle passioni deve divenire abitudine; e questo si traduce in una serie di precetti – dati nel cosiddetto Manuale di Epitteto – tra cui la parsimonia nel ridere, la castità prima del matrimonio, la morigeratezza verso i divertimenti, la modestia etc. Epitteto dice:
è segno di scarse qualità morali perdere tempo dietro le cure del corpo […] tutta la nostra attenzione va rivolta alla mente […] Il filosofo ha eliminato da se stesso qualsiasi desiderio […] verso ogni cosa ha un impulso moderato […] in una parola, si guarda da se stesso, come da un nemico insidioso. (Manuale, 33-48; corsivo mio)
Lo stoicismo insegna dunque l’assoluta diffidenza verso la degenerazione della ragione in passione e l’abbandono alla pura razionalità (nonché al logos universale che governa il mondo per il meglio). Il giudizio morale è prodotto esclusivo della ragione; la passione non può essere un elemento di formazione del giudizio, ché essa è una deviazione della ragione stessa, i.e. un giudizio scorretto.
1.5 Plotino
Plotino, filosofo del III secolo a.C., padre del neoplatonismo, recupera la separazione interna all’anima propria della filosofia platonica, giungendo per altro a esiti similmente estremi quanto quelli stoici. Nelle Enneadi troviamo l’idea della necessità di una fuga dal mondo malvagio, e della tensione verso la realtà divina, attraverso la vita buona secondo ragione. Plotino ci parla di virtù purificatrici, che consistono nel purificarsi dal contagio del corpo per dedicarsi al divino; nelle virtù dell’anima già purificata, la temperanza consiste non tanto nel reprimere le passioni, quanto proprio nell’obliarle, e la fortezza consiste nell’ignorarle piuttosto che nel vincerle. Questo tipo di uomo virtuoso in sostanza deve operare un diniego impensabile della propria condizione corporea, alla vecchia maniera stoica. Se la morte consiste nell’essere relegati negli inferi, e la vita consiste nello stare in compagnia dei Superi, e allora la vita dell’anima è la morte del corpo, la morte dell’anima è la vita del corpo (infatti l’uomo muore quando l’anima esce dal suo corpo, e l’anima muore quando entra nel corpo), segue che la nostra vita terrena è morte, il corpo stesso con le sue passioni è morte per l’anima, e la nostra vera vita è proiettata in una dimensione ultramondana, dove l’improbabile psicologia morale del greco può finalmente vedersi realizzata.
Nelle Enneadi, summa del pensiero di Plotino raccolto dall’allievo Porfirio, troviamo anche l’idea – per altro sorta di anticipazione del pensiero psicoanalitico dell’inconscio – che in ogni individuo vi sono tre uomini. 1) l’uomo interiore o vero uomo. Costui è la parte dell’anima che non è discesa dalla suo luogo di origine, dove sta a contatto con il Pensiero e dunque con l’Uno. Questo primo uomo può esserci inconscio dal momento che la coscienza risiede nel secondo uomo; 2) l’uomo intermedio fra le dimensioni dell’anima e del corpo. È la ragione (conscia). Quest’uomo deve combattere il terzo uomo (che anch’esso può essere inconscio): 3) il terzo uomo è la parte sensibile, pulsionale e passionale dell’anima. Il nostro io, la nostra identità, noi stessi, risiediamo propriamente nel secondo uomo. Ritorna la vecchia idea dell’io come ragione, questa volta con la possibilità di proiettarsi, così fuggendo la parte corporea di noi stessi, verso il regno della purezza. L’uomo deve cercare di ritirare l’anima dal corpo, di allontanarla dalle passioni verso la dimensione del puro pensiero. La sublimazione dell’anima permette così di andare oltre la virtù, dal momento che questa si può dare solo dove v’è contrapposizione tra i diversi uomini da cui l’uomo è composto. Si tratta di diventare simili a dei, i quali possono anche fare a meno della virtù, in quanto l’hanno superata. Qui l’estremità del pensiero di Plotino è simile per intensità a quella dello stoico. E i due pensieri convergono: la ragione supera e deve superare la sfera della passione. Anche per Plotino il corpo è malattia. È malattia perché è male, e male in quanto materia, i.e. quanto di più lontano v’è dall’Uno e dal Bene. L’uomo non deve dimenticare la propria origine. La sua anima viene dal lassù sede di Pensiero e Uno, dove in un certo senso rimane, se non per prolungare una sua parte nel mondo terreno, ove l’uomo però corre il serio pericolo di perdere se stesso. Il percorso di discesa dell’anima verso la corruzione della materia va invertito: bisogna riportare l’anima lì da dove è partita, astraendo quanto più dalla dimensione corporea e irrazionale. Inutile dire che questo porta in definitiva ad astrarre dalla propria individualità, per cui nella contemplazione dell’Uno non rimane più nulla di se stessi.
Con Plotino possiamo chiudere la breve presentazione della filosofia morale antica, e concludere col dire che questa nel suo complesso è omogenea nell’accordare alla ragione il ruolo di guida nel processo di presa di decisione e azione morale, e nel vedere la passione non molto più che un elemento di disturbo, che al massimo può fare, se adeguatamente sottomessa ed educata, da schiava alla ragione.
[1] La questione qui è come si decide di tagliare il concetto di razionalità.
[2] O anche ‘passione’, ‘sentimento’; generalmente questi termini sono usati come sinonimi di ‘emozione’ da gran parte della filosofia.
[3] Si può sostenere che la razionalità dell’emozione dipenda dalla particolare situazione in cui ci si trova.
[4] Questo non significa che sia da trascurare come l’emozione viene intesa dalla filosofia, ma che il come viene intesa è solo un particolare che compone il quadro d’insieme che vogliamo comprendere.
[5] Entrambe le comprensioni chiariscono la risposta della filosofia alla nostra domanda.
[6] Così Husserl nelle lezioni sull’etica del 1920/1924.




Be First to Comment